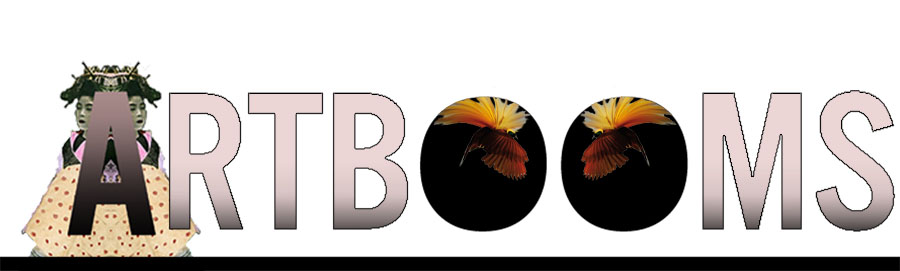Anish Kapoor, Void Pavilion VII, 2023; tecnica mista, vernice, mixed media, paint; cm 750 × 750 × 750 Images: © photo Ela Bialkowska OKNO studio. Credists: Palazzo Strozzi and the artist
Ideato appositamente per il cortile di Palazzo Strozzi (Firenze) in occasione della mostra “Untrue-Unreal”, “Void Pavillion VII”, (Padiglione del Vuoto) dell’artista anglo-indiano Anish Kapoor, non è solo una straordinaria opera d’arte pubblica (accessibile a tutti gratuitamente per l’intera durata dell’esposizione) ma un vero e proprio concentrato di cultura contemporanea che riempie il cuore tardo- quattrocentesco dell’edificio simbolo del Rinascimento. Più di una sfida, quasi un duello.
C’è la psicanalisi, l’ambiguità del pensiero, le avanguardie storiche (sotto forma del Quadrato nero di Kazimir Malevič definito da molti il “punto zero della pittura" da cui Kapoor trae ispirazione per quest’opera), l’evoluzione della scienza, la ricerca sul colore, l’esplorazione del cosmo, la crisi delle fedi, l’individualismo, la dimensione nomade delle arti visive. E che la volta celeste della Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, di Brunelleschi in persona, con tutto il suo ordine e la sua armonia, vada pure in frantumi! Tanto se si entra in mostra, al piano Nobile di Palazzo Strozzi, non si potrà non incontrare, “Angel”, con le sue lastre d’ardesia adagiate a terra come una pigra costellazione di isole ricoperte di pigmento blu, che paiono proprio grandi frammenti di cielo.
“Void Pavilion VII- ha detto Kapoor- è una struttura formale che fa rima con il palazzo. È un piccolo edificio realizzato per contenere il vuoto o l’oscurità, per dare spazio al non formato o al nascosto. Un luogo per l’unheimlich (l’inquietante ndr): forse in questo senso l’opposto di ciò che intendevano i costruttori di Palazzo Strozzi”.
Il lavoro, settima opera incentrata sul concetto di padiglione del vuoto ed ennesima a servirsi del discusso super-nero che Kapoor usa in esclusiva, è infatti composto da una stanza di un bianco quasi accecante con ingresso ad est, che contiene tre rettangoli neri (uno per parete). Ognuno di essi ha le stesse proporzioni. ma in scala ridotta, della porta (come fosse appunto la sua proiezione nella griglia prospettica rinascimentale). Una sottigliezza formale che serve a tenere insieme l’opera, certo, ma anche un modo per alludere alle dualità contrapposte che sono una vera e propria fissazione di Kaoor (il vuoto che diventa pieno, la forma che non ha forma ecc.)
“L’intera visione indiana della vita è incentrata sulle forze opposte. Una cosa che mi affascinava [durante il viaggio che l’artista fece in India del 1979] erano i piccoli santuari e templi lungo la strada, che si trovavano dappertutto in India, e sono specificamente ispirati da questa concezione dualistica”.
Figlio di un generale cartografo induista nato in Pakistan e immigrato in India prima che il figlio nascesse e di una sarta irachena di religione ebraica, Anish Kapoor, ha visto la luce a Mumbai e ha familiarità con la cultura indiana. Anche se non vi è stato esposto molto a lungo. Infatti, dopo aver vissuto qualche anno in un kibbutz ad Israele e aver passato la maggior parte della sua vita adulta in Occidente (soprattutto il Regno Unito dove l’artista ha studiato e risiede fin dagli anni ’70, ma anche l’Italia dove ha uno studio, una casa, e una fondazione che porta il suo nome e sarà operativa dal prossimo anno) Kapoor è molto lontano dal pensiero della patria scelta dai genitori. E proprio questo suo sentirsi sradicato, apolide, è una delle ragioni che l’ha portato in analisi per un lungo periodo di tempo. Viene da sé che il suo lavoro ne abbia fortemente risentito.
“Il vuoto è in realtà uno stato interiore. Ha molto a che fare con la paura, in termini edipici, ma ancora di più con l’oscurità. Non c’è niente di più nero del nero interiore. Nessun altro nero è paragonabile a quello [...]. Questo vuoto non è qualcosa privo di importanza. È uno spazio potenziale, non un non-spazio”.
In “Void Pavilion VII” queste riflessioni dell’artista si percepiscono con forza, e non solo perché i tre rettangoli che i visitatori incontrano nella stanza allestita per accoglierli sono dipinti di nero. Ma perché lo spazio e l’essenzialità dei lavori è lì proprio per spingere a meditare a guardare in faccia l’abisso nascosto nel profondo di ognuno di noi. Kapoor non si accontenta di una singola finestra nera, ne mette tre (un riferimento agli antichi polittici), uno per parete. Costringendoci a girare in cerca di un appiglio.
“Questo è ciò che voglio- ha spiegato parlando in generale del suo lavoro- il passaggio da un oggetto nell’architettura a un’architettura in sé”.
C’è da dire che il nero dei rettangoli non è un nero comune ma il discusso Vantablack (inventato nel 2014 dagli scienziati dell’inglese Surrey NanoSystems per uso militare, è stato acquistato da Kapoor in esclusiva e rinominato Kapoorblack suscitando polemiche, tanto accese che l’artista Stuart Semple ha a sua volta brevettato dei colori che tutti potevano comperare tranne Kapoor). Un colore talmente scuro da essere più nero di un buco nero, capace di nascondere qualsiasi cosa ci sia sotto di lui comprese le forme (in questo senso le opere che lo utilizzano si possono leggere come una cupa cosmogonia senza stelle ma anche come un luogo dove le possibilità sono infinite). Una sorta di barriera e uno spazio di meditazione capace di renderci consapevoli degli inganni che ci giocano i nostri sensi, di terrorizzarci con i suoi riferimenti a mancanza e morte, ma anche di riconnetterci con le nostre energie primigenie. D’altra parte è l’artista stesso a chiedersi: “Dov'è lo spazio reale dell’oggetto? È quello che si sta guardando o è lo spazio al di là di quello che si sta guardando?”.
Come il quadrato di Malevič le opere in cui Anish Kapoor usa il suo super-nero hanno qualcosa di profondamente spirituale. Non fa eccezione “Void Pavillion VII”, (Padiglione del Vuoto) che fino al 4 febbraio 2024 occuperà il cortile di Palazzo Strozzi di Firenze. Una straordinaria opera d’arte pubblica nata per celebrare l’importante personale “Untrue-Unreal” (in corso fino alla stessa data) che Kapoor ha impiegato anni a preparare.
Anish Kapoor, Void Pavilion VII, 2023; tecnica mista, vernice, mixed media, paint; cm 750 × 750 × 750 Images: © photo Ela Bialkowska OKNO studio. Credists: Palazzo Strozzi and the artist
Anish Kapoor, Void Pavilion VII, 2023; tecnica mista, vernice, mixed media, paint; cm 750 × 750 × 750 Images: © photo Ela Bialkowska OKNO studio. Credists: Palazzo Strozzi and the artist
Anish Kapoor, Void Pavilion VII, 2023; tecnica mista, vernice, mixed media, paint; cm 750 × 750 × 750 Images: © photo Ela Bialkowska OKNO studio. Credists: Palazzo Strozzi and the artist
Anish Kapoor, Void Pavilion VII, 2023; tecnica mista, vernice, mixed media, paint; cm 750 × 750 × 750 Images: © photo Ela Bialkowska OKNO studio. Credists: Palazzo Strozzi and the artist
Anish Kapoor, Void Pavilion VII, 2023; tecnica mista, vernice, mixed media, paint; cm 750 × 750 × 750 Images: © photo Ela Bialkowska OKNO studio. Credists: Palazzo Strozzi and the artist
Anish Kapoor, Void Pavilion VII, 2023; tecnica mista, vernice, mixed media, paint; cm 750 × 750 × 750 Images: © photo Ela Bialkowska OKNO studio. Credists: Palazzo Strozzi and the artist