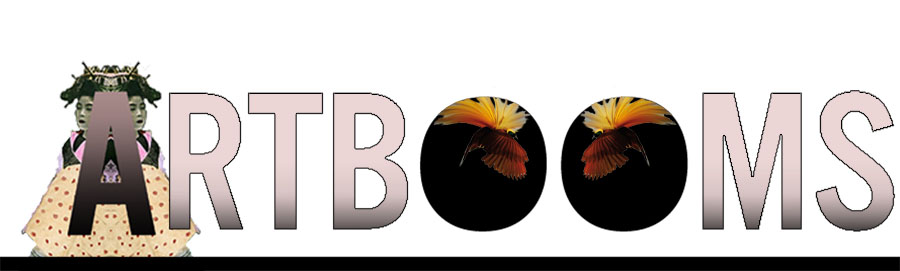La facciata del del Padiglione Centrale rallegrata dal murale del collettivo MAHKU 60. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere Photo by: Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia
Il tempo incerto della seconda metà di aprile ha fatto bene alle piante, e gli alberi dei Giardini accolgono con tutte le possibili sfumature di verde riflesse nelle acque argentee della laguna i visitatori della 60esima Esposizione internazionale d’Arte, che durante lo scorso fine settimana (il primo di apertura della Biennale di Venezia 2024) hanno superato tutti i record precedenti. Sono anche delle perfette quinte vegetali per l’elegante facciata del Padiglione Centrale che quest’anno appare completamente ridisegnata, sfolgorante di audaci colori tropicali, da un murale del collettivo MAHKU (il Movimento degli Artisti Huni Kuin, cioè una popolazione amazzonica che abita tra Brasile e Perù, nella regione dell’alto Rio Jordão). Gli autori hanno impiegato 45 giorni per completarlo (niente in confronto ai mesi che sono occorsi ad Archie Moore, meritatissimo Leone d’Oro per le Partecipazioni Nazionali, solo per disegnare col gesso sulle pareti del padiglione Australia un albero genealogico in cui è risalito di 65mila anni!)
Un particolare del monumentale albero genealogico tracciato a mano da Archie Moore Archie Moore / kith and kin 2024 / Australia Pavilion at Venice Biennale 2024 / Photographer: Andrea Rossetti / © the artist / Image courtesy of the artist and The Commercial
E questo è soltanto un piccolo assaggio dell’imponente lavoro che si troverà di fronte il pubblico di “Stranieri Ovunque- Foreigners Everywere” di Adriano Pedrosa, una Biennale che ha riunito le opere di oltre 300 artisti (Pedrosa in un’intervista ha detto: “Volevo dare ad ognuno una possibilità, forse per questo ne ho selezionati così tanti.”) provenienti da ogni dove (ma soprattutto dall’America Latina), spesso indigeni, nella stragrande maggioranza dei casi sconosciuti al grande pubblico.
E non poteva essere altrimenti, visto che Pedrosa, attualmente direttore del Museo d’arte di San Paolo del Brasile, ha bypassato musei e gallerie (abituali fornitori di informazioni in queste circostanze) viaggiando personalmente in Angola, Repubblica Domenicana, Bolivia, Indonesia e Guatemala per trovarli (“Penso di essere stato il primo curatore a farlo” ha detto a Radio 3).
Il tema, che ricalca il titolo, ha tre chiavi di lettura: una politica, una psicologico-poetica e una linguistica. Per questo, in mostra trovano ampio spazio gli artisti indigeni (stranieri nella propria patria), gli artisti queer (stranieri rispetto a un modello sociale binario) e gli outsider (stranieri, tra l’altro, rispetto ai canoni della storia dell’arte). L’aspetto più profondo di questa riflessione è sicuramente il restare estranei a sé stessi, ed è forse il meno immediatamente leggibile, ma la mano misurata e sicura di Pedrosa riesce a dare tridimensionalità anche alla lettura più immediata (quella politica) bilanciando con le tribolazioni dell’essere sradicati dalla propria cultura l’affermazione di uguaglianza globalista. Un’alchimia per niente facile.
Un dipinto di Kay WalkingStick al Padiglione Centrale Photo © artbooms
Ne è uscita una Biennale unica, narrativa, artigianale, fatta di dipinti e di tessuti, luccicante di lustrini, densa di segni, carica di bellezza, a momenti illuminata da brillanti colori pastello o rallegrata da vivaci cromie, altre mimetica, in sintonia coi toni di rocce, terreni argillosi e muschi di foreste o aree desertiche. Ci sono poche sculture e diversi video, (spesso inseriti per fluidificare il percorso, dando il tempo al visitatore di fermarsi a metabolizzare la moltitudine di immagini condensate negli spazi precedenti). Una mostra in un certo senso sospesa tra passato e presente, che ha contagiato con il suo forte tema (quello degli stranieri, delle minoranze, degli svantaggiati) tutte le partecipazioni nazionali, in cui le nuove tecnologie non avrebbero potuto trovare spazio, ma che, forse per questo, spinge la contemporaneità ad emergere prepotente e ad apparire inaspettata: nell’ologramma transgender- canterino della Svizzera, nei cartelloni digitali che stanno fuori a Francia e Gran Bretagna; ma anche nel padiglione Israele tristemente chiuso e presidiato da una coppia di militari (dopo molte polemiche sono stati i curatori a decidere di non aprire anche perché temevano manifestazioni di dissenso filo-palestinese) non lontano dalla Russia che, quest’edizione, ha ceduto il suo edificio alla Bolivia, senza neppure fare un comunicato per spiegare le ragioni di questa scelta. Tensioni geopolitiche che crepitano e si specchiano nella Biennale.
Il pubblico sotto il neon del collettivo Claire Fontaine all'esterno del Padiglione Centrale 60. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere Photo by: Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia
Lo spirito del tempo, tuttavia, non impedisce al passato di rivendicare la propria importanza nelle vicende del presente. Così i neon del collettivo italo-francese, Claire Fontaine, che hanno ispirato il titolo della manifestazione, incontrano il pubblico all’ingresso dei Giardini per poi tornare a mettersi in vista all’Arsenale, mentre, sospesi sull’acqua, appongono il riflesso della frase “Stranieri Ovunque” (in tutte le lingue e i colori primari) nelle onde dell’antica darsena.
Il passato, d’altra parte, è un elemento importante di questa Biennale che, prima di sondare il presente, si propone di restituire alla storia dell’arte pagine perdute. Di regalare uno sguardo critico diverso agli osservatori di oggi, sulla base di una rivalutazione di tecniche, stili, concetti e tradizioni artistiche a cui nessuno fino ad ora aveva mai prestato attenzione (semplicemente perché succedevano al di fuori dell’Occidente). Un lavoro che continua e completa quello cominciato da Cecilia Alemani ne “Il Latte dei Sogni” (lei si era occupata delle opere perdute o sottovalutate perché firmate da donne, Pedrosa di quelle di creativi che hanno operato nel sud del mondo).
Forse proprio per questo gli artisti scomparsi sono oltre la metà di quelli chiamati a partecipare. C’è il nucleo storico che si sviluppa in quattro sale ma anche all’interno di quello contemporaneo i morti sono tanti.
“Crucifixion of the Soul” di Madge Gill Photo © artbooms
Tre gruppi di opere del nucleo storico sono ai Giardini, dove per tradizione viene esposto il materiale più datato (una sala dedicata all’astrazione queer, una al ritratto e una agli artisti italiani del XX secolo che si sono avventurati in Paesi allora considerati remoti e minacciosi). Ma, come già detto, anche quelli del nucleo contemporaneo a volte non ci sono più. E’ il caso dell’inglese Madge Gill, per la prima volta esposta alla Biennale, con lo splendido “Crucifixion of the Soul” (1936). Artista outsider, Gill, ben rappresenta la chiave di lettura psicologico-poetica del tema “Stranieri Ovunque” (essere estranei a se stessi), era infatti convinta che la sua mano fosse pilotata da uno spirito guida. “Crucifixion of the Soul” è un monumentale esempio del suo stile: fittissimo disegno veloce ed energico ad inchiostro da cui emergono figure femminili, scale e motivi a scacchiera.
Uno dei Bamboos di Ione Saldanha Photo © artbooms
Non è più tra noi (dal 2001) anche la brasiliana Ione Saldanha che ha esplorato nuovi supporti pittorici per il suo lavoro. Uno di questi è stato il bamboo, che l’artista raccoglieva e seccava per più di un anno per poi sabbiarlo e ricoprirlo con cinque rivestimenti preparatori di pittura bianca. Alla fine lo dipingeva con motivi astratti e colori vivaci. Queste opere che sono una via di mezzo tra pittura e scultura si chiamano “Bambus” e sono pensate per essere appese al soffitto e fluttuare al passaggio dei visitatori.
Sempre al Padiglione Centrale i dipinti di paesaggi naturali americani, ad un tempo meta turistica e patria ancestrale degli indiani-americani, della statunitense Kay WalkingStick (di padre cherokee), oltre alle rappresentazioni dell’infinita varietà di alberi della foresta amazzonica di Abel Rodríguez (formatosi come botanico presso gli indigeni colombiani Nonuya). Ma anche gli assemblaggi scultorei tagliati con la motosega dal coreano-argentino Kim Yun Shin che, a 88 anni, ha trovato una galleria di riferimento per il suo lavoro solo quest’anno.
Delle sculture di Kim Yun Shin esposte nel Padiglione Centrale 60. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere Photo by: Matteo de Mayda Courtesy: La Biennale di Venezia
Se i Giardini si possono definire un tiepido inizio è all’Arsenale che Pedrosa dimostra tutto il suo talento di regista. Non una nota stonata, non un cedimento, ogni scelta stilistica (se così si può dire) è perfetta: l’equilibrio tra spazi pieni e vuoti nell’installazione, tra stanze colme di oggetti ed altre concepite per fermare il visitatore, dargli il tempo di prendere fiato e ripartire di nuovo ricettivo. Persino i colori dei gruppi di quadri alle pareti non sembrano lasciati al caso e si abbinano bene a vicenda.
Qui si parte con un’installazione del collettivo di donne māori della Nuova Zelanda, Mataaho, fatta di fasce in poliestere e fibbie in acciaio, tese a proiettare una successione di righe d’ombra e luce senza soluzione continuità sulle pareti dell’antico ex-edificio industriale veneziano. L’opera, che si è aggiudicata il Leone d’Oro al miglior partecipante, si intitola “Takapau”, come una stuoia tradizionalmente usata dagli indigeni durante il parto e che segna perciò un momento di transizione fra luce e buio.
Ma i lavori da segnalare sarebbero davvero troppi, dai “trapuntos” della filippino-statunitense Pacita Abad, ai dipinti carichi di sfumature fantascientifiche di verde che sottraggono all’oscurità i personaggi queer della stella emergente pakistano-americana, Salman Toor. E poi dipinti e sculture della poetessa visiva austriaco-italiana (vive a Bologna) Greta Schödl che ricopre interamente gli oggetti con una singola parola ripetuta più e più volte (ad esempio su un pezzo di granito incide reiteratamente la parola “granito”) da cui isola una lettera su cui applica della foglia d’oro. Senza dimenticare le splendide fotografie del boliviano, River Claure, che nella sua serie più conosciuta “Warawar Wawa” (2019-2020) ambientava il “Piccolo Principe” nella Bolivia contemporanea.
Un particolare dell’installazione premiata “Takapau” del collettivo Mataaho Photo © artbooms
Poi i tessuti ariosi, dai colori tenui e sorprendenti, ottenuti anche con pigmenti naturali, della keniota Agnès Waruguru; l’enorme installazione idraulica effimera del colombiano-francese, Daniel Otero Torres, fatta di oggetti recuperati qua e là, messi insieme per evocare il sistema di architettura a palafitte degli Emberà (stanziati lungo le rive del fiume Atrato, in Colombia), e progettata per raccogliere l’acqua piovana e fornire agli abitanti acqua non inquinata. E ancora, l’artista autodidatta peruviano, Santiago Yahuarcani, che dipinge con pigmenti naturali complesse scene che non fanno riferimento alla storia dell’arte occidentale ma a quanto narrato dai suoi antenati, alla conoscenza sacra delle piante medicinali, ai suoni della giungla e ai miti del suo popolo. Yahuarcani, che appartiene al clan dell’Airone Bianco della Nazione Uitoto (indigeni dell’Amazzonia settentrionale), era presente all’inaugurazione della Biennale e si è messo davanti ai suoi quadri a spiegare pazientemente alle persone di passaggio il perché di ogni singola immagine nelle complesse composizioni. In mostra c’è anche suo figlio, Rember Yahuarcani (e non sono gli unici due partecipanti legati da vincoli di sangue), che crea paesaggi onirici dai colori vivaci che tendono all’astrattismo e sono stati invece influenzati dall’arte dell’occidente.
Santiago Yahuarcani spiega al pubblico incontrato in Biennale il perchè delle rappresentazioni che animano le sue grandi opere Photo © artbooms
La parte dell’esposizione sviluppata all’Arsenale si conclude con una stanza dedicata interamente all’opera di un’altra stella nascente, il giovane artista statunitense di origini orientali, WangShui, che qui presenta dai grandi pannelli ossidati manualmente con la cocciniglia posti a schermare le finestre (solo una lama di luce filtra da ogni lato), insieme ad una grande scultura di led che pulsa ed emette suoni e rumori. L’effetto è straniante e drammatico.
Usciti di lì i visitatori troveranno non molto lontano il Padiglione Italiano (di cui Artbooms parlerà diffusamente più avanti), intitolato “Due qui / To Hear”, una installazione scultoreo-sonora, risolta con uno stile pulito dall’artista Massimo Bartolini, e davvero ben riuscita. Il curatore è Luca Cerizza. Bravi entrambi!
Al margine del giardino che completa il padiglione Italiano (che è stato pensato come una terza stanza e contiene un’ultima, impalpabile, opera di Bartolini) non va dimenticato di entrare nel piccolo edificio che ospita l’installazione site-specific, “Indo e Vindo”, dell’italiana di nascita ma brasiliana d’adozione, Anna Maria Maiolino, Leone d’oro alla carriera di quest’anno. Una quantità impressionante d’argilla modellata a mano ma anche suoni e odori che evocano l’inesauribile vitalità della natura e il ciclo della vita.
“Stranieri Ovunque- Foreigners Everywere” di Adriano Pedrosa resterà a Venezia fino al 24 novembre e va assolutamente visitata. Sia perché si tratta di una splendida mostra che ha comportato un lavoro colossale, ma anche e soprattutto perché dopo questa Biennale (così come dopo quella che l’ha preceduta) la critica e la storia dell’arte non saranno più le stesse. Non potranno esserlo. Anche se nella prossima edizione dovesse essere nominato un curatore dall’approccio più convenzionale semplicemente non gli sarà possibile fare come se niente fosse. La 60esima Esposizione internazionale d’Arte è destinata ad avere un prima e un dopo.
Una ragazza osserva le opere di Abel Rodríguez al padiglione Centrale Photo © artbooms
Salman Toor, Night Grove, 2024 Oil on panel 195.6 × 267 cm 60. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere Photo by: Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia
Particolare di un'opera di Greta Schödl 60. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere Photo by: Marco Zorzanello Courtesy: La Biennale di Venezia
Un particolare della stanza dedicata a WangShui che completa il percoso all'Arsenale 60. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere Photo by: Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia
Un'opera di River Claure Photo © artbooms
Daniel Otero Torres Aguacero , 2024 Mixed media 655 × 1100 × 1100 cm 60. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere Photo by: Marco Zorzanello Courtesy: La Biennale di Venezia
Un particolare dell'installazione “Indo e Vindo”, del Leone d'oro alla carriera Anna Maria Maiolino Photo © artbooms