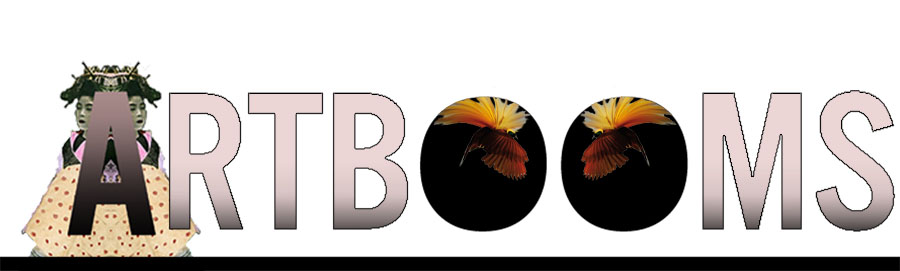Pavilion of ITALY DUE QUI / TO HEAR 60th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia Photo by: Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia
A “Due qui / To Hear”, il Padiglione Italia di Massimo Bartolini per la 60esima Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, si può accedere da due ingressi. L’artista originario di Cecina (provincia di Livorno) insieme al curatore milanese, Luca, Cerizza, hanno voluto così alludere alla circolarità (del pensiero, dell’esistenza, della storia ecc.) e permettere ai visitatori che arrivano dal giardino di pertinenza dell’edificio (quest’anno trattato come una sala) così come a chi viene dall’ingresso interno all’Arsenale, di incrociarsi nella stanza più grande, quella che ne costituisce il fulcro. Quest’ultima interamente occupata dall’installazione sonora e scultorea, “Due qui” (fatta di ponteggi tramutati in canne d’organo, piante di antichi giardini riadattati in percorsi verso la scoperta di sé) e dalla fontana, “Conveyance” (in cui un’onda conica non smette mai di alzarsi al centro di un cerchio di marmo) è davvero bella. L’intero padiglione lo è.
Magari è firmato da un uomo bianco occidentale, che lavora con un linguaggio tipicamente maschile e tipicamente occidentale come il minimalismo (la cui durezza è appena smussata dal buddismo e dalle filosofie orientali), che nel cuore della biennale della decolonizzazione può apparire un po’ fuori posto, ma è sicuramente un bellissimo padiglione. Uno dei più riusciti delle ultime edizioni.
Anche il carattere del tema “Stranieri Ovunque”, scelto dal curatore della manifestazione lagunare Adriano Pedrosa (da intendersi in più modi fino al sentirsi “stranieri a sé stessi”), è qui interpretato in maniera diversa: “(…) proponendo- hanno scritto gli organizzatori- un’ulteriore declinazione per la quale il non essere straniero deve iniziare con il non essere stranieri a se stessi”. Il titolo, infatti, partendo dalla traduzione apparentemente sbagliata, “Two here” (due qui) e To hear (sentire/udire), suggerisce come l’ascoltare, il “tendere l’orecchio”, sia già una forma di azione verso l’altro. E come le incomprensioni possano essere occasione di scoperta.
Di certo le polemiche che hanno accolto l’inaugurazione della mostra di Bartolini non lo sono.
L’Italia quest’anno viene rappresentata da un solo artista, è la seconda volta nella storia della Biennale che succede (la prima in assoluto è stata nella scorsa edizione) e a qualcuno la cosa non è piaciuta. Le altre nazioni, occidentali e non (sia che dispongano di padiglioni grandi, o che si adattino a spazi angusti), vengono rappresentate da un solista da decenni, perché è una formula vincente (chi espone è valorizzato, il pubblico capisce meglio, la stampa è più propensa a parlare dell’evento). L’unico Paese che non lo fa è la Repubblica Popolare Cinese (anche lei ha un padiglione che in genere, per quanto riguarda le arti visive, fa poco parlare di sé). Per esempio, alla 60esima Esposizione Internazionale d’Arte, nei Giardini (dove ci sono tutti i padiglioni più antichi e visitati), solo la Germania ha scelto di non veicolare il proprio messaggio attraverso una sola voce (ma due, non quattro o quaranta, a cui sono state comunque allestite mostre separate). Nelle edizioni precedenti però, pure quest’ultima, ha preferito delle personali. Insomma, questo non è un argomento che lascia spazio a pareri divergenti, come dimostrano le scelte adottate dagli altri Paesi.
“Due qui / To Hear” era inoltre inadatta a queste critiche. Infatti, sebbene la firma del progetto sia quella di Bartolini, all’opera hanno partecipato anche le musiciste: Caterina Barbieri (italiana, classe 1990) e Kali Malone (statunitense, nata nel ‘94). Oltre al famoso compositore inglese, Gavin Bryars (del ’43) insieme al figlio, Yuri Bryars (nato nel ’99). Ci sono poi due testi commissionati appositamente per il progetto alla scrittrice e illustratrice per l’infanzia Nicoletta Costa (italiana, del ‘53) e al romanziere e poeta Tiziano Scarpa (italiano a sua volta ma del ‘63).
Se si accede dall’Arsenale, il Padiglione Italia, accoglie i visitatori con un minimalismo disarmante. Nella stanza c’è solo una piccola statua in bronzo di un Pensive Bodhisattva (una rappresentazione classica del Buddha, in cui il principe appare assorto e distaccato) collocata all’estremità di un lungo parallelepipedo bianco. Quest’ultimo elemento, che può alludere alla strada compiuta da Siddharta per raggiungere l’illuminazione, è in realtà una canna d’organo che attraverso un ventilatore è in grado di produrre un suono prolungato e continuo. I visitatori, però, se ne accorgono solo passandogli accanto e credono di percepire anche vibrazioni che li disorientano. Le pareti circostanti sono dipinte di verde e viola; i colori, secondo un’antica usanza, invece di costituire un abbellimento, indicano delle note musicali (in questo caso La e La bemolle)
“Lo stesso tempo sospeso- ha scritto a proposito dell’opera il curatore, Luca Cerizza- suggerito dal Bodhisattva è rafforzato da questo suono prolungato, che rimanda a un tempo circolare”.
Pavilion of ITALY DUE QUI / TO HEAR 60th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia Photo by: Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia
Ma è la seconda stanza (quella centrale considerando anche il giardino) a lasciare stupiti: di fronte a sé un labirinto di pali per ponteggio in metallo che evoca una cattedrale effimera e luccicante da attraversare percorrendo stretti viottoli. I tubi però sono stati modificati uno ad uno per trasformarsi in canne d’organo (“grazie alla collaborazione di organari e tecnici specializzati”) e suonano al passaggio del pubblico, mentre le melodie composte dalle musiciste Barbieri e Malone, vengono diffuse in loop da due rulli a motorie, che funzionano come grandi carrilon. La pianta dell’installazione, in questa sala, rimanda ai giardini italiani barocchi, mentre i visitatori sono chiamati ad attivare l’opera in maniere potenzialmente infinite: “il suono di questa macchina musicale- continua Cerizza- è percepibile in modi sempre diversi a seconda dei tempi e direzioni di percorrenza dello spettatore. È il nostro movimento a ‘comporre’ parzialmente una musica sempre nuova”.
Al centro della stanza c’è una fontana in marmo (“Conveyance”). Inutile dire che si tratta di un’opera strettamente minimalista, composta da due cerchi concentrici (la vasca e la seduta da cui i visitatori possono contemplarla). L’acqua qui non si perde in giochi, si limita a un’onda conica: “Chiamata in termini scientifici ‘solitone’, è un’onda simile a quella che genera uno ‘tsunami’ ma replicata di continuo come in un esperimento di laboratorio.” A differenza di quanto si potrebbe pensare la fontana è silenziosa (è anzi il punto più propizio per ascoltare le melodie che si alzano dalla foresta di tubi) e se guardata abbastanza a lungo dovrebbe predisporre alla meditazione.
Massimo Bartolini, Due qui, 2024 12×6×50 m 50 minutes of music / 10 minutes of silence iron, cast iron, motors, electronics Music composed by: Caterina Barbieri, Kali Malone Metalwork and engineering: Yari Andrea Mazza Detailed design: Riccardo Rossi Organ builders: Massimo Drovandi, Samuele Frangioni, Samuele Maffucci Electronics: Valerio Marrucci Scaffolding assembly: Euroedile, Postioma (TV) (Alessandro Ballan, Denis Daullja, Fabiano Gregolin, Nicola Lazzari, Vasyl Ozhibko, Rinor Krasniqi, Vitali Serbin) Courtesy the artist, Massimo De Carlo, Frith Street Gallery and Magazzino Photo © Agostino Osio / AltoPiano
Usciti da questa stanza ci si trova nel giardino. In alcuni punti del quale si attivano le melodie dei Bryars ma il pubblico può anche fermarsi ad osservare un cerchio di persone coi piedi sotterranti che cingono un albero (“Lo proteggono e lo contemplano allo stesso tempo, diventando un pubblico che custodisce”). La performance non c’è sempre ma l’installazione sonora si, e accompagna con grazia il passaggio delle persone in mezzo agli alberi secolari.
Nato nel ’62, Massimo Bartolini, che stranamente continua a vivere e lavorare a Cecina, ha una carriera di tutto rispetto alle spalle. Prima di quest’anno ha già partecipato tre volte alla Biennale di Venezia (ma mai da solista). Nel 2012, invece, è stato ospite a Documenta di Kassel. E’ anche insegnate (alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e all’Accademia di Belle Arti di Bologna).
Per concludere, “Due qui / To Hear”, il Padiglione Italia di Massimo Bartolini va assolutamente visitato. Per quanto non sia la partecipazione nazionale più inerente al tema della la 60esima Esposizione Internazionale d’Arte (anzi tra i Paesi occidentali forse è una delle meno consonanti sia stilisticamente che concettualmente), è di certo una gran bella mostra. Inoltre, l’idea di permettere ai visitatori l’ingresso anche dal giardino di pertinenza dell’edificio, potrebbe permettere a qualcuno di sveltire i tempi di attesa per accedere a questa parte della Biennale di Venezia 2024.
Massimo Bartolini, Pensive Bodhisattva on A Flat, 2024 2500×32×32 cm, statue 40×9×9 cm 50 minutes of music / 10 minutes of silence wood, motor, bronze Organ builders: Massimo Drovandi, Samuele Frangioni, Samuele Maffucci Courtesy the artist, Massimo De Carlo, Frith Street Gallery and Magazzino Photo © Agostino Osio / AltoPiano
Pavilion of ITALY DUE QUI / TO HEAR 60th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia Photo by: Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia
Pavilion of ITALY DUE QUI / TO HEAR 60th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia Photo by: Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia
Pavilion of ITALY DUE QUI / TO HEAR 60th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia Photo by: Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia
Massimo Bartolini, Due qui, 2024 12×6×50 m 50 minutes of music / 10 minutes of silence iron, cast iron, motors, electronics Music composed by: Caterina Barbieri, Kali Malone Metalwork and engineering: Yari Andrea Mazza Detailed design: Riccardo Rossi Organ builders: Massimo Drovandi, Samuele Frangioni, Samuele Maffucci Electronics: Valerio Marrucci Scaffolding assembly: Euroedile, Postioma (TV) (Alessandro Ballan, Denis Daullja, Fabiano Gregolin, Nicola Lazzari, Vasyl Ozhibko, Rinor Krasniqi, Vitali Serbin) Courtesy the artist, Massimo De Carlo, Frith Street Gallery and Magazzino Photo © Agostino Osio / AltoPiano
Massimo Bartolini, Due qui, 2024 12×6×50 m 50 minutes of music / 10 minutes of silence iron, cast iron, motors, electronics Music composed by: Caterina Barbieri, Kali Malone Metalwork and engineering: Yari Andrea Mazza Detailed design: Riccardo Rossi Organ builders: Massimo Drovandi, Samuele Frangioni, Samuele Maffucci Electronics: Valerio Marrucci Scaffolding assembly: Euroedile, Postioma (TV) (Alessandro Ballan, Denis Daullja, Fabiano Gregolin, Nicola Lazzari, Vasyl Ozhibko, Rinor Krasniqi, Vitali Serbin) Courtesy the artist, Massimo De Carlo, Frith Street Gallery and Magazzino Photo © Agostino Osio / AltoPiano
Pavilion of ITALY DUE QUI / TO HEAR 60th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia Photo by: Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia
Massimo Bartolini, A veces ya no puedo moverme, 2024 variable dimensions 6 boomboxes, mixer Music composed by: Gavin and Yuri Bryars Percussions: Gavin and Yuri Bryars Voices: Alessandra Fiori, Francesca Santi, Silvia Testoni Sound engineering: Louis McGuire Production assistant: Emanuele Wiltsch Barberio La Biennale di Venezia team: Paolo Zanin, Michele Braga, Dario Sevieri, Enrico Wiltsch Recorded at Cosmogram, Giudecca, Venice, February 24 and 25, 2024 Courtesy the artist, Massimo De Carlo, Frith Street Gallery, and Magazzino Photo © Agostino Osio / AltoPiano
Massimo Bartolini con l’opera Pensive Bodhisattva on A Flat (Bodhisattva pensieroso su La bemolle), 2024, all’interno del Padiglione Italia – Biennale Arte 2024 Foto © Agostino Osio per AltoPiano