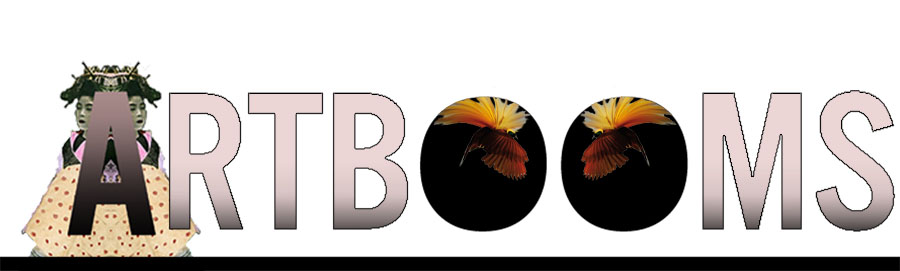Bharti Kher, Ancestor, 2022 (detail). Collection of the Kiran Nadar Museum of Art, Delhi. Courtesy the artist, Hauser & Wirth, Nature Morte and Perrotin. Photo © Jonty Wilde, courtesy Yorkshire Sculpture Park
Quando Bharti Kher teminò gli studi era indecisa se trasferirsi negli Stati Uniti o in India: lanciò una moneta e uscì l’india; lì tre mesi dopo avrebbe incontrato il suo futuro marito (l’artista indiano Subodh Gupta, da cui ha poi avuto due figli). Nata e cresciuta a Londra da una coppia di immigrati del Punjab, Kher allora (era l’inizio degli anni ’90), la patria dei suoi antenati l’aveva visitata una sola volta da bambina e in giro per le strade si faceva capire a fatica, ma andò tutto nel migliore dei modi. In quest’episodio, si può scorgere anche il segno della dualità che da sempre modella il suo lavoro. Poeticamente sospeso nell’equilibrio instabile tra fissa determinazione del pensiero e apparente imprevedibilità del fato.
Un bilanciamento che a volte richiede pronta flessibilità intellettuale. Così quando nel 2008, alla vigilia dell’inaugurazione di una mostra in un museo inglese (il Baltic Centre for Contemporary Art di Gateshead) il pezzo forte dell’esposizione, una scultura in fibra di vetro simile a un albero ("The Waq Tree") alta 5 metri è crollata, Kher l’ha lasciata a terra, senza farne parola con nessuno (qualche anno dopo raccontò che sul momento si era messa a piangere ma poi il marito l’aveva esortata a non scoraggiarsi e, di fronte all’opera ferita, si era resa conto che, in fondo, in quella nuova posizione stava anche meglio di prima).
Dalla fine di giugno l’artista anglo-indiana è protagonista di una vasta retrospettiva allo Yorkshire Sculpture Park di West Bretton in Inghilterra. Intitolata “Bharti Kher: Alchemies”, la mostra, si estende tra gli spazi espositivi interni e gli splendidi giardini del museo che celebrano la bellezza della campagna inglese in ogni stagione. Lì, tra le altre grandi opere tridimensionali, c’è anche “Ancestor” (lo scorso anno posizionata nel Central Park di New York), una donna simile a una divinità indiana, accanto alla cui testa escono quelle di 23 bambini. Descritta da Kher come "una forza femminile mitica e potente che rende omaggio alle generazioni precedenti e successive". Anche lei, però, frutto di una mediazione tra la volontà dell’artista e i capricci del destino.
L’idea della serie “Intermediaries” (di cui “Ancestor” fa parte), infatti, le venne alcuni anni fa durante una visita alla cittadina portuale di Kochi nell’India meridionale: "Ho visto tutte queste meravigliose bambole golu (statuette tradizionali della zona, spesso esposte durante le feste religiose n.d.r.)- ha detto a Vogue India- Ho chiesto a un artigiano locale di raccoglierne alcune per me, ma quando sono arrivate nel mio studio, molte erano rotte".
Bharti Kher, Virus XV, 2024. Courtesy the artist, Hauser & Wirth, Nature Morte and Perrotin. Photo © Jonty Wilde, courtesy Yorkshire Sculpture Park
D’altra parte l’opera di Kher fa continuamente riferimento a trasformazione e metamorfosi (di concetti, di natura e di materiali). Cui allude anche il titolo della mostra (“Alchemies”), in cui sono esposte molte opere, realizzate appunto, in maniera ingannevole (le imponenti “Intermediaries”, per esempio, imitano delle fragili statue di terracotta ma sono in metallo, sembrano antiche ma non lo sono affatto). Mentre l’artista affronta il tema dell’identità e quello della spiritualità. Ma anche cose meno universali: “Sono una persona politica- ha spiegato in un’altra intervista- ma non reagisco alle situazioni man mano che accadono. L'arte non è un'azione impulsiva. È più simile a una combustione lenta. Ciò che facciamo quando creiamo arte è distillare e condensare. Condenso molto rumore e ricerca in un singolo momento".
L’elemento più conosciuto della sua pratica è il bindi (dal sanscrito bindu, che significa goccia, particella, punto, cioè il principio di tutto e non per niente queste decorazioni sono dette anche terzo occhio) con cui ha ricoperto l’immagine di un elefante morente a grandezza naturale (l’opera è poi diventata un record d’asta), ma anche dipinti astratti, specchi frantumati e quant’altro.
Tradizionalmente usato dalle donne indiane, il bindi un tempo ne indicava lo stato civile ma anche quello religioso ed etnico, mentre oggi viene principalmente usato come decorazione. Nell’opera di Kher è un simbolo complesso: fa riferimento all’identità privata (le donne alla sera lo tolgono) e a quella pubblica; al femminile e al maschile (spesso i suoi bindi sono a forma di serpente o spermatozoo); oltre che alla resilienza imperfetta delle tradizioni di fronte all’erosione di significato della globalizzazione (i bindi del presente sono spesso ninnoli a basso costo prodotti in ogni dove).
Ma Kher ha lavorato anche con altri oggetti-simbolo della femminilità nel subcontinente, come i bracciali di vetro e i sari. Riguardo a questi ultimi ha detto: "I sari custodiscono le storie delle nostre vite; il singolo pezzo di tessuto che indossi per tutta la vita, alla fine diventa il tuo sudario".
La serie di opere dedicate a quest’indumento si intitola “Sari Women” e, quasi sempre, rappresenta una figura femminile in scala uno a uno, di cui solo i piedi o le gambe sono visibili, mentre il resto del corpo (volto compreso) è nascosto da pile di tessuti drappeggiati (la bellezza e la violenza della negazione; l’assenza).
Allo Yorkshire Sculpture Park c’è più di una scultura di questa serie e, nonostante si tratti di lavori emotivamente disturbanti, non riescono a raggiungere il livello di vibrazione suscitata dalla semplicità funeraria di “The Deaf Room” (2001-2012) in cui l’artista ha costruito una stanza con mattoni scuri, ottenuti dalla fusione di 10 tonnellate di braccialetti di fibra di vetro usati. L’opera fa riferimento alle rivolte religiose nel Gujarat del 2002 in cui la violenza contro le donne era pratica diffusa.
In mostra pure il toccante calco in gesso di sei prostitute di New Delhi (“Six Women”, 2012-2014), restituite agli occhi del pubblico, nude, in una posa raccolta.
Del resto il genere femminile è protagonista dell’esposizione inglese di Kher che raffigura le signore in maniera molteplice e ambivalente. Il museo spiega l’argomento così: “Presenta la donna come madre, prostituta, mostro, guerriera e divinità, spesso ibridata con animali o come avatar della dea. I suoi personaggi mitologici confondono i confini tra genere umano, natura e narrazione, rivelando un potenziale espansivo e un nuovo significato”.
“Bharti Kher: Alchemies” resterà allo Yorkshire Sculpture Park fino al 27 aprile 2025.
Bharti Kher, The Intermediary Family, 2018. Courtesy the artist, Hauser & Wirth, Nature Morte and Perrotin. Photo © Jonty Wilde, courtesy Yorkshire Sculpture Park
Bharti Kher, Alchemies, installation view at Yorkshire Sculpture Park, 2024. Courtesy the artist Hauser & Wirth, Nature Morte and Perrotin. Photo © Jonty Wilde, courtesy Yorkshire Sculpture Park.
Bharti Kher, Djinn, 2024. Courtesy the artist, Hauser & Wirth, Nature Morte and Perrotin. Photo © Jonty Wilde, courtesy Yorkshire Sculpture Park
Bharti Kher, Alchemies, installation view at Yorkshire Sculpture Park, 2024. Courtesy the artist Hauser & Wirth, Nature Morte and Perrotin. Photo © Jonty Wilde, courtesy Yorkshire Sculpture Park.
Bharti Kher, Six Women, 2012– 2014. Courtesy the artist, Hauser & Wirth, Nature Morte and Perrotin. Photo © Jonty Wilde, courtesy Yorkshire Sculpture Park
Bharti Kher, The deaf room, 2001–2012 (detail). Courtesy the artist, Hauser & Wirth, Nature Morte and Perrotin. Photo © Jonty Wilde, courtesy Yorkshire Sculpture Park
Bharti Kher with Djinn, 2024. Courtesy the artist Hauser & Wirth, Nature Morte and Perrotin. Photo © Jonty Wilde, courtesy Yorkshire Sculpture Park.