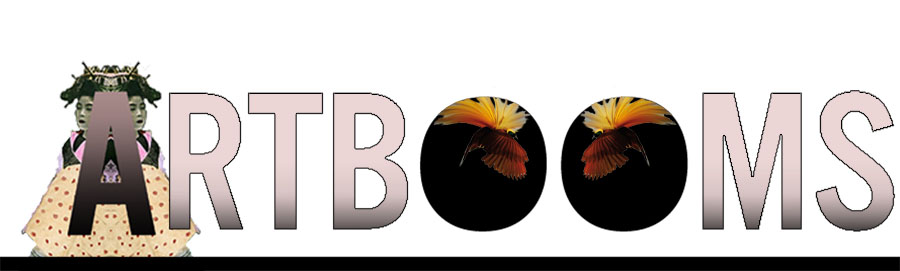Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Quando nel 2005, Mohamed Bourouissa, si è imposto nel panorama internazionale con la serie fotografica “Périphérique” in cui ambientava nelle banlieue parigine contemporanee scene iconiche della pittura storica francese (più spesso quella di Delacroix), nessuno immaginava che nel tempo il suo lavoro si sarebbe fatto così ramificato. Sempre in bilico tra il trauma e la cura, Bourouissa, attualmente protagonista dell’importante retrospettiva “Signal” al Palais de Tokyo di Parigi, parla di razzismo, migrazioni, confinamento e postcolonialismo, con uno spirito errante e, tutto sommato, più attento alle dinamiche interiori che a quelle sociali e politiche.
Non che a Bourouissa, nato nel ’78 a Blida (nel nord dell’Algeria) ed emigrato in Francia insieme alla madre quando aveva appena cinque anni, queste ultime non interessino. Lui nelle banlieue c’è cresciuto. Ma non è un uomo superficiale, gli piace guardare le cose da più punti di vista, come si evince dalla sua opera che si dirama in direzioni sempre diverse (senza perdere mai il centro però). E poi i sentimenti raggiungono più in fretta il nocciolo della questione, e nell’artista franco-algerino c’è anche un lato pratico, che vuole catturare lo spettatore subito, senza tergiversare.
E di certo ci riesce con “Brutal Family Roots”. Realizzata nel 2020 per la Biennale di Sidney e riproposta anche quest’anno a Parigi, un’opera che in genere presenta su un pavimento giallo dorato come i fiori della mimosa che ne è l’elemento ispiratore e il vero e proprio soggetto. Bourouissa, infatti, quando ha pensato questa installazione era appena venuto a sapere che la pianta, il cui profumo e aspetto gli richiamava alla mente lontani frammenti della sua infanzia mediorientale, era in realtà originaria dell’Australia dove gli indigeni Wiradjuri la chiamano garal. Lui che ha un debole per le piante e le storie della loro diffusione ci ha visto la prova lampante degli equilibri frantumati dal colonialismo. Tempo fa ha detto: “(…) vediamo le piante come oggetti piuttosto che come soggetti, ‘Brutal Family Roots’, esamina il modo in cui dividiamo in categorie esseri umani, piante e animali”. Così ha trovato il modo per dare voce alle mimose sdradicate dalla loro terra natia su navi inadatte a trasportarle: ha messo in musica le frequenze che emettono. Anche il rap si è spostato per il mondo, spesso mettendo radici in comunità disagiate. “Brutal Family Roots” unisce queste due storie in un mix composto dalle melodie emesse dalle piante e i testi dei rapper che parlano di vento e acqua.
Nello stesso anno, Bourouissa, si è inventato anche un’opera esclusivamente sonora: “HARa!!!!!!hAaaRAAAAA!!!!!hHAaA!!!” Uno strano grido che si ispira al termine ‘hara’ usato a Marsiglia per avvisare gli spacciatori dell’arrivo della polizia. L’opera l’ha spiegata così: “È una forma di segnale, come un allarme. Senza il contesto può significare qualcos'altro: per me questo lo rende più simile all'Urlo di Edvard Munch, ad esempio, o al primo pianto di un bambino, o al segnale di allarme quando qualcuno tenta di entrare in casa tua. È qualcosa di molto semplice, qualcosa di forte.”
Anni prima, invece, l’artista era stato in Algeria dove aveva avuto modo di conoscere, Bourlem Mohamed, paziente psichiatrico dell’ospedale di Blida del medico e filosofo politico radicale, Franz Fanon (scomparso nel ’61, tra le altre cose si interessò di psicopatologia della colonizzazione e sostenne la lotta per l’indipendenza dell’Algeria). Bourlem si occupava di un giardino che aveva creato da solo e che, secondo Bourouissa, era una proiezione della sua mente. L’artista con Bourlem Mohamed ha fatto un film (“The Whispering of Ghosts”) e ispirandosi a quanto appreso da quest’ultimo, in molte sue mostre costruisce un giardino (ce n’è uno anche a Parigi).
Ma Mohamed Bourouissa è anche scultore (per esempio, ha ideato una serie che ritrae solo il tocco di un corpo da parte di una mano, facendo riferimento alle dinamiche dell’arresto e della prevaricazione), acquarellista (dipinge carte coloratissime e crede siano un modo per esprimere pensieri inconsci), oltre che esperto fotografo e regista (anche teatrale).
Un’altra sua opera che non si può non citare è il progetto “Horse Day”. Quando è rimasto un anno a Filadelfia, per far emergere e raccontare le antiche radici della cultura ippica di una comunità afroamericana del luogo.
Tutti questi lavori sono parte di “Signal”, mostra pensata non in modo cronologico, ma come un paesaggio da attraversare.
La retrospettiva di Mohamed Bourouissa rimarrà al Palais de Tokyo di Parigi fino al 30 giugno 2024.
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024
Vue d'exposition, Mohamed Bourouissa, SIGNAL, Palais de Tokyo, 16.02.2024 - 30.06.2024. Crédit photo Aurélien Mole. © ADAGP, Paris,2024