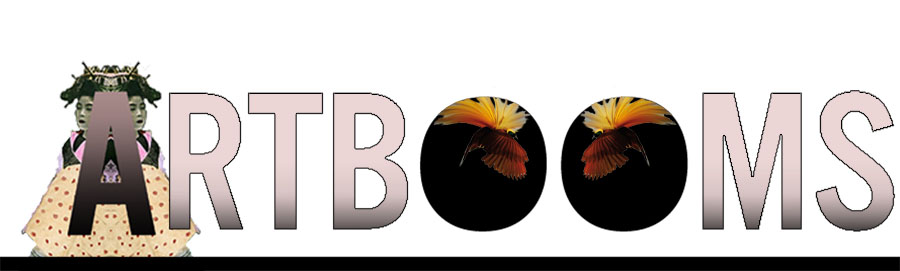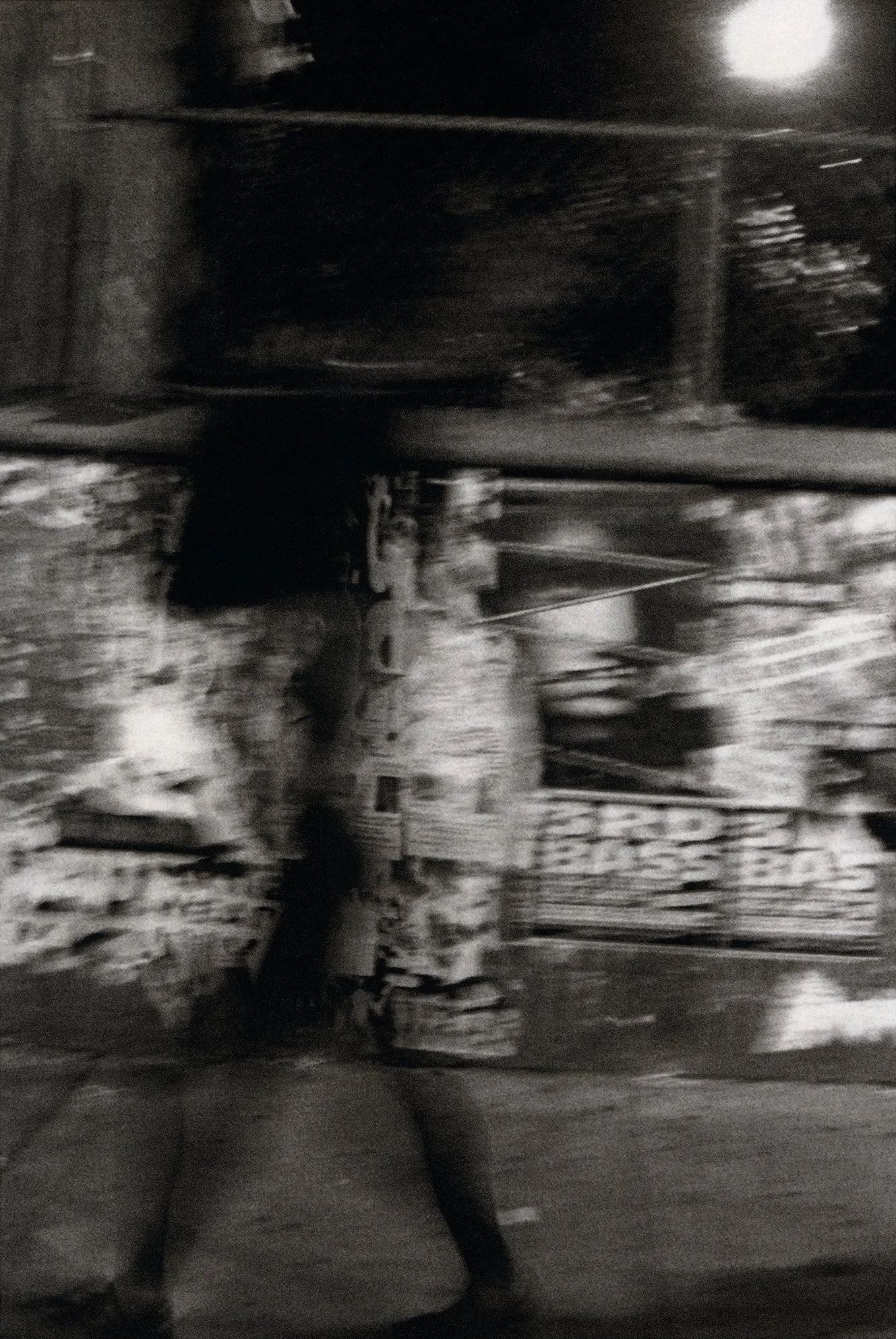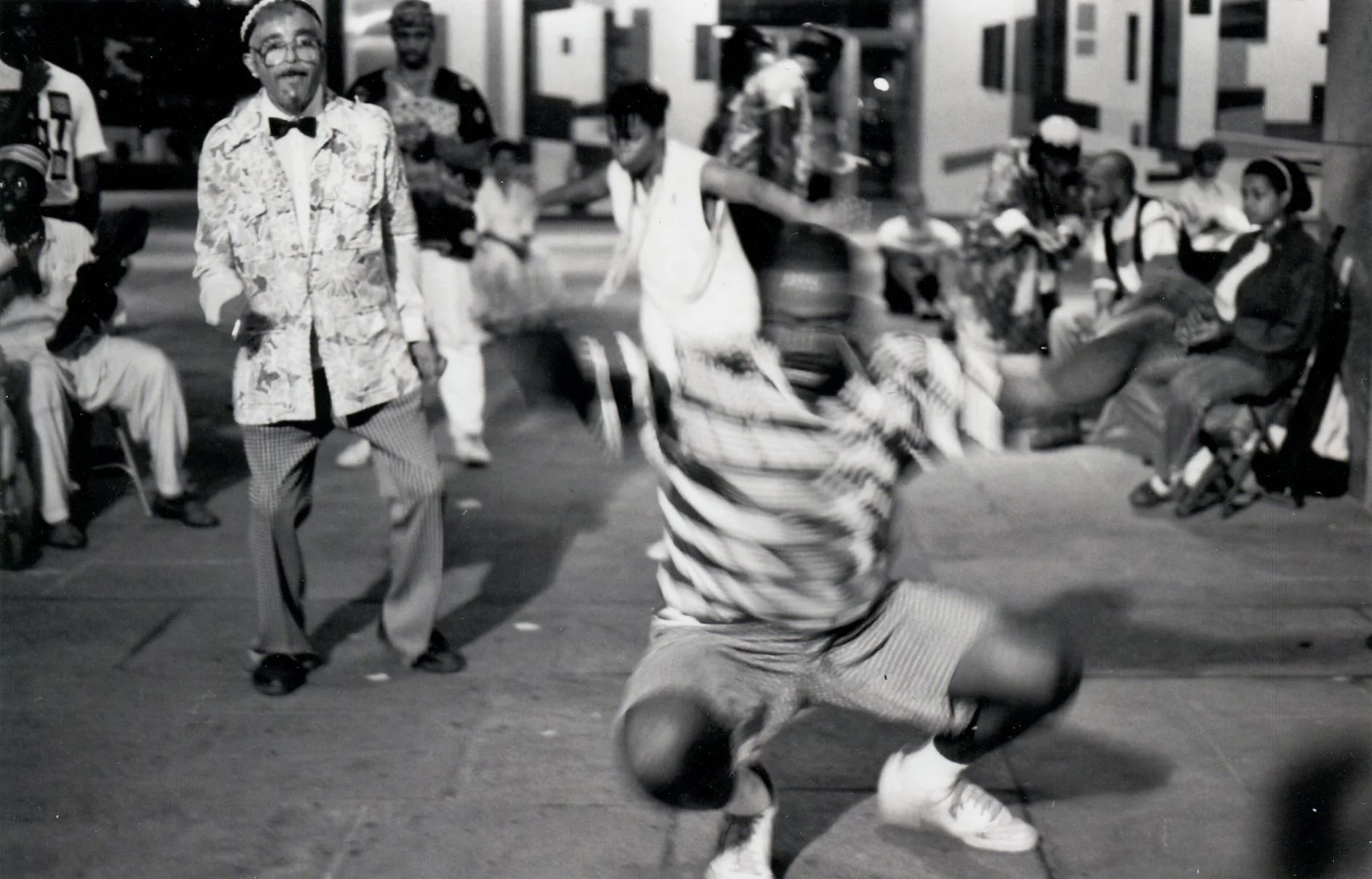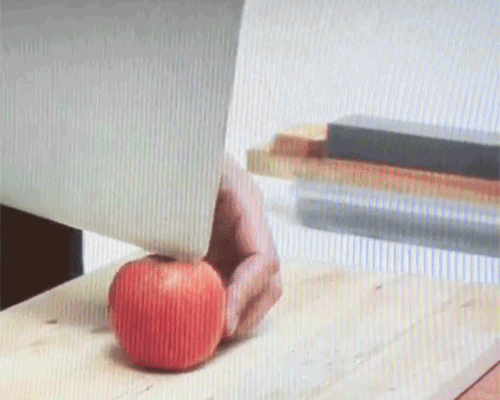Dopo l’attesissimo concerto-anteprima alla Triennale di Milano, Meredith Monk, sarà al Pirelli Hangar Bicocca per parlare della sua amicizia con Bruce Nauman (ancora al centro del prestigioso spazio espositivo con la mostra “Neons Corridors Rooms”), di quanto l’arte dell’uno abbia preso da quella dell’altra e viceversa, ma anche della retrospettiva "Meredith Monk. Calling" che il prossimo autunno vedrà il suo lavoro sessantennale protagonista dell’ Haus der Kunst di Monaco di Baviera.
Converserà con Andrea Lissoni (il direttore italiano del famoso museo d’arte contemporanea tedesco che ospiterà la sua mostra), e l’evento sarà ad ingresso gratuito.
Si tratta di un appuntamento importante perchè Meredith Monk è una figura cardine della performance art. Pluripremiata, insignita da numerosi riconoscimenti tra cui la National Medal of Arts (che le conferì Barack Obama) e l'investitura a Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres della Repubblica Francese.
Nata nel ‘42 a New York City, Meredith Jane Monk è compositrice, cantante, regista, coreografa e filmmaker. La sua musica è stata utilizzata nel film "Il grande Lebowski" dei fratelli Coen, in "Nouvelle Vague" e "Notre musique" di Jean-Luc Godard. Figlia d’arte, la madre, infatti, era cantante professionista e i nonni materni musicisti. Monk, è stata una pioniera di quella che oggi viene chiamata "tecnica vocale estesa" (che prevede l’utilizzo di particolari tecniche timbriche e armoniche per ampliare la tavolozza dei suoni) e "performance interdisciplinare". In sostanza, ha esplorato con la voce territori fino ad allora inesplorati e nel contempo l’ha mixata con il movimento del corpo. Le sue performance, sono spesso concepite o adattate in funzione dello spazio in cui si esibisce, rendendo effimera e ancora più carica poeticamente la sua virtuosa arte.
Il sito internet della statunitense, in proposito dice: "Crea opere che prosperano all'intersezione di musica e movimento, immagine e oggetto, luce e suono, scoprendo e intrecciando nuove modalità di percezione. La sua innovativa esplorazione della voce come strumento, come linguaggio eloquente in sé e per sé, espande i confini della composizione musicale, creando paesaggi sonori che portano alla luce sentimenti, energie e ricordi per i quali non ci sono parole”. Lei invece ha spesso dichiarato che intende “la musica così visivamente”.
Per il Teatro della Triennale si esibirà, in compagnia di due tra le sue collaboratrici più fidate, in una scelta di brani che abbracciano cinquant’anni della sua produzione, da “Songs from the Hill” (1975-1976) e “The Games” (1984) fino ai più recenti “Mercy” (2001) e “Cellular Songs” (2018). Lo spettacolo, che si intitola semplicemente "Meredith Monk in concerto con Katie Gissinger e Allison Sniffin", si terrà sabato 18 febbraio alle 19 e 30. I biglietti sono in vendita sul sito della Triennale.