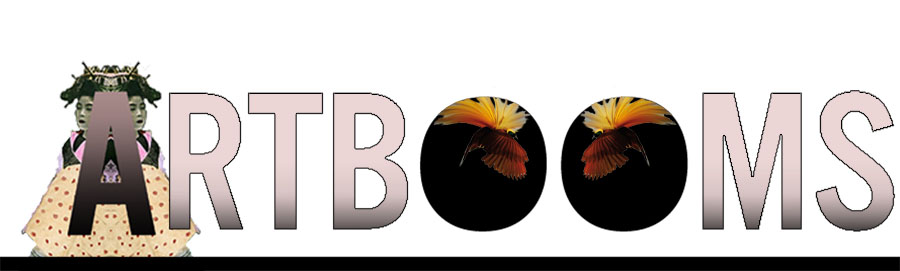Bozar When We See Us Credit: Julie Pollet
In un parco apparentemente distante dal traffico cittadino un ragazzo e una ragazza si concentrano l’uno sull’altra, il loro atteggiamento è rilassato, intenerito, forse stanno chiacchierando e malgrado si possa immaginare il tono scuro della loro pelle, le innumerevoli sfumature di blu che compongono l’immagine rendono la caratteristica una vaga congettura. Non molto lontano, invece, un uomo mette in risalto la sua carnagione nerissima con un completo turchese, una camicia bianca e un fiore arancio, è vanitoso (si intuisce fiero di essere guardato), mentre appare al centro di un dipinto dai toni vivi, quasi caraibici.
Sono protagonisti diversi di opere diverse. Tutti però accumunati dall’essere neri, colti in un momento ordinario (diventato straordinario attraverso l’arte). E felici di essere vivi.
Il romantico pic-nic monocromatico (“Blue Park Lovers”) dell’artista originario del Missuri (che adesso vive in Connecticut) Dominic Chambers; e il ritratto variopinto (“View of Yoei William”) del ghanese-statunitense, Otis Kwame Kye Quaicoe; sono solo due delle innumerevoli interpretazioni della blackness espresse in “When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting”. La mostra, che si è inaugurata il 7 febbraio scorso al Centro per le Arti Bozar di Bruxelles (Belgio), curata da Koyo Kouoh e Tandazani Dhlakama, è infatti, un affresco senza tempo ne luogo sull’autorappresentazione nera.
Malgrado “When We See Us”, ideata e promossa dallo Zeitz MOCAA di Città del Capo (il museo sudafricano diretto dal critico camerunense, Koyo Kouoh), sia stata già allestita lo scorso anno al Museo d’Arte di Basilea (Svizzera), è balzata al centro dell’interesse del pubblico internazionale da quando la signora Kouoh è stata nominata curatrice della Biennale di Venezia del prossimo anno (quello belga è il primo evento europeo a sua firma da allora).
Dominic Chambers, Blue Park Lovers, 2020. Jorge M. Pérez Collection, Miami © Courtesy of the artist and Luce Gallery
La mostra, che ispira il proprio titolo alla famosa serie Netflix del 2019 “When They See Us” della regista Ava DuVernay, espone opere di artisti africani, afroamericani e della diaspora, per di più nati in periodi storici molto differenti (il lavoro più antico è datato 1930 mentre il più recente è di appena due anni fa). D’altra parte “When We See Us”, chiarisce di non avere pretese ortodosse, nel momento in cui rinuncia a disporre in successione cronologica le opere, e a raggrupparle in base al paese di origine o di residenza degli artisti, ma sceglie invece di dividere il materiale in sei capitoli diversi (Quotidianità; Riposo; Trionfo ed Emancipazione; Sensualità; Spiritualità; Gioia e Svago) accumunati da un approccio nuovo all’argomento.
“When We See Us”, infatti, rispetto alla serie di DuVernay (afroamericana anche lei; racconta la storia vera di un gruppo di bambini di colore ingiustamente condannati per un grave reato che non avevano commesso) decide di dar conto della gioia di essere neri.
Koyo Kouoh e la co-curatrice della mostra Tandazani Dhlakama, hanno così spiegato la loro scelta: "Questa mostra si rifiuta di mettere in primo piano il dolore e l'ingiustizia e invece ci ricorda che l'esperienza dei neri può anche essere vista attraverso la lente della gioia. Per celebrare il modo in cui gli artisti africani e della sua diaspora hanno immaginato, posizionato, commemorato e affermato le esperienze africane e degli afrodiscendenti, la mostra contribuisce al discorso critico sui movimenti di liberazione, intellettuali e filosofici africani e neri".
Bozar When We See Us Credit: Julie Pollet
La signora Kouoh sembra poi dirci che il mondo è piccolo e quello dell’arte lo è ancora di più: gli artisti di colore (come gli altri, del resto) si informano e si guardano vicendevolmente, alla ricerca di un’identità nera condivisa, ma soprattutto nel tentativo di trovare le travi portanti di una storia dell’arte a loro misura.
I numeri di “When They See Us”(in effetti piuttosto impressionanti) si spiegano proprio in quest’ottica. Con 52 prestatori provenienti da 17 paesi e 5 continenti, l’esposizione, presenta la bellezza di 155 opere di 118 artisti diversi. Alcuni conosciuti (ci sono ad esempio: la famosa pittrice britannica Lynette Yiadom-Boakye; oltre agli afroamericani Kehinde Wiley ed Amy Sherald che vennero scelti per fare i ritratti ufficiali dell’ex presidente Obama e dell’allora first lady) altri meno. Tanto diversi che l’autodidatta afroamericana Clementine Hunter (nata in Luisiana nel 1887 e scomparsa a 99 anni dopo aver lavorato in una piantagione e conosciuto il successo artistico in tarda età) è esposta insieme alla sudafricana ventiseienne, Zandile Tshabalala.
Sempre da questo punto di vista va guardata la cronologia grafica in mostra (che dalla Rivoluzione haitiana arriva al movimento Black Lives Matter). E il paesaggio sonoro del compositore e sound artist sudafricano Neo Muyanga, che riecheggia di musiche provenienti da tutto il mondo in risposta ai vari capitoli della mostra.
Stilisticamente, invece, si può dire che la signora Kouoh abbia preferito dar voce a una moltitudine di dialetti della stessa lingua madre, visto che pur esponendo artisti figurativi (il più delle volte pittori) ci fa notare quanto le loro forme espressive si discostino le une dalle altre con tessuti e glitter che fanno la loro comparsa accanto a pennellate e tavolozze ben distinte.
Pur se tutte le opere sono accostate o giustapposte per mettere in luce nuove similitudini (che senza il loro incontro non sarebbe stato possibile cogliere)
“Nell'ultimo decennio- ha detto la curatrice- la pittura figurativa di artisti neri ha raggiunto una nuova importanza nell'arte contemporanea. Non c'è momento migliore per una mostra di questa natura, che collega queste pratiche e rivela i contesti storici più profondi e le reti di genealogie artistiche complesse e sottorappresentate che derivano dalle modernità africane e nere; una mostra che dimostra come più generazioni di tali artisti si siano deliziate e si siano impegnate in modo critico nel proiettare varie nozioni di nerezza e africanità”.
Le opere poi, lungi dall’essere appese su muri bianchi senza nulla che distragga lo sguardo, sono evidenziate da pareti intensamente laccate, con colori in qualche modo contrastanti per rendere ancora più drammatico il passaggio da un punto di vista all’altro. Anche in questo Koyo Kouoh dimostra momenti di contatto con lo stile curatoriale del brasialiano Adriano Pedrosa (dirige il Museu de arte de São Paulo e ha firmato la scorsa edizione della Biennale di Venezia).
“When We See Us”, esteticamente, è una mostra dalla forte personalità e, malgrado sia fuori dagli schemi, non rinuncia né a lavorare su una Storia dell’arte in versione black, né a riflettere sugli strumenti di lavoro necessari ad una nuova critica. Come testimoniano le tante pubblicazioni messe a disposizione dei visitatori (monografie, cataloghi di mostre, testi di teoria critica e raccolte, compresi scritti importanti che hanno plasmato il canone storico dell'arte nera). La scelta di evitare il solito copione (incluso il razzismo) poi, è segno di una acuta sensibilità (molto femminile) che sottolinea la forza, la libertà e l’autosufficienza delle persone di colore.
“When We See Us” è il risultato dell’ampia ricerca di Koyo Kouoh sull’arte nera e rimarrà nelle spaziose sale dell’edificio liberty in cui ha sede il Bozar (nel cuore del quartiere reale di Bruxelles) fino al 10 agosto 2025. All’esposizione il museo ha affiancato eventi di ogni genere (concerti, conferenze, dibattiti, aperture notturne, visite guidate, film, spettacoli, e persino videogiochi).
Bozar When We See Us Credit: Julie Pollet
Otis Kwame Kye Quaicoe, View of Yoei William, 2020.© Courtesy the artist and Roberts Projects, Los Angeles, California; Foto Mario Gallucci
Bozar When We See Us Credit: Julie Pollet
Wangari Mathenge (b.1973, Nairobi, Kenya) Sundials and Sonnets 2019 Oil on canvas CollecƟon of Pascale M. Thomas and Tayo E. Famakinwa, courtesy of Roberts Projects, Los Angeles, California © Courtesy of the arƟst and Roberts Projects, Los Angeles, California; Photo Robert Wedemeyer
Bozar When We See Us Credit: Julie Pollet
Thenjiwe Niki Nkosi (b.1980, New York City, USA) Ceremony 2020 Oil on canvas Courtesy of Homestead CollecƟon © Thenjiwe Niki Nkosi. Courtesy of Stevenson, Amsterdam/Cape Town/Johannesburg. Photo Nina Lieska
Bozar When We SeeUs Credit: Julie Pollet
Zandile Tshabalala (b.1999, Soweto, South Africa)Two Reclining Women 2020 Acrylic on canvas Courtesy of the Maduna CollecƟon © Zandile Tshabalala Studio
Bozar When We See Us Credit: Julie Pollet
BOZAR, When We See Us Photo credit: We Document Art
BOZAR, When We See Us Photo credit: We Document Art
Koyo KOUOH, portrait. Courtesy of Zeitz MOCAA