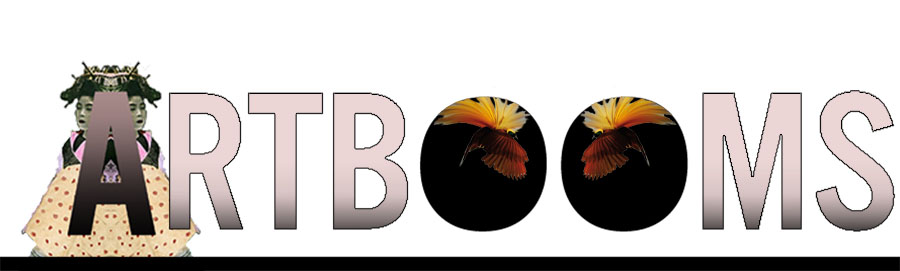Installation view of Thomas Schütte, on view at The Museum of Modern Art, New York from September 29, 2024 through January 18, 2025. Photo: Jonathan Dorado.
Nell’estate del 1972, Thomas Schütte, che allora aveva 17 anni ed era in procinto di scegliere cosa avrebbe fatto da grande, visitò due volte di fila Documenta (un’importante manifestazione d’arte contemporanea che si tiene a scadenza quadriennale nella cittadina di Kassel, in Germania) e rimase folgorato. Aveva preso la sua decisione. In seguito disse: “A Kassel, ho visto per la prima volta tutta la varietà di possibilità nel mondo dell'arte”. Ed oggi, tanti anni dopo, quegli orizzonti sconfinati di opzioni, fatte le debite proporzioni, sono diventati la cifra distintiva dell’opera di Schütte. Amata e odiata per una eterogeneità che contribuisce a renderla difficile da cogliere a pieno. Che ne fa anzi un universo misterioso, non necessariamente benevolo, a tratti imperscrutabile.
Ma un luogo in cui vale la pena entrare e che va celebrato. Lo ha fatto lui stesso aprendo un museo di 700 metri quadri nei pressi di Düsseldorf (città in cui vive e lavora) che ha anche disegnato (inaugurato nel 2016 espone pure altri artisti). Lo ha fatto la Biennale di Venezia, che, già nel 2005, gli ha conferito il Leone d’Oro. E in occasione del suo settantesimo compleanno (che cade il 16 del mese prossimo) lo stanno facendo alcuni tra i più prestigiosi musei del mondo.
La Beyeler Foundation di Riehen (Basilea) ha inserito il suo lavoro nella collettiva “Daughter of Freedom” (che propone un riallestimento di modernisti e contemporanei di loro proprietà) destinando alla scultura del tedesco una sala dedicata. Ma soprattutto lo ha fatto il Museum of Modern Art di New York (il famoso MoMa) con una retrospettiva che ripercorre cinquant’anni di carriera di Thomas Schütte attraverso sculture, disegni, stampe, esperimenti di architettura e che occupa l’intero sesto piano dell’edificio. Organizzata da Paulina Pobocha (curatrice senior di Robert Soros presso l'Hammer Museum di Los Angeles ed ex curatrice associata del MoMA) e da Caitlin Chaisson (assistente curatrice del Dipartimento di pittura e scultura del MoMA), è la sua prima mostra nella Grande Mela da oltre vent’anni.
La prossima primavera, invece, sarà la volta del Museo di Punta della Dogana a Venezia. Anche in questo caso si tratterà di un grande show con opere che dagli esordi porteranno ai giorni nostri.
Installation view of Thomas Schütte, on view at The Museum of Modern Art, New York from September 29, 2024 through January 18, 2025. Photo: Jonathan Dorado.
Nato nel ’54 ad Oldemburg (una cittadina a nord-est della Germania), Thomas Schütte, non ha vissuto il periodo della guerra, se non attraverso i racconti degli altri. Il padre (come tutti i tedeschi del resto) aveva combattuto per Hitler e, secondo quanto riportato dal figlio, forse perché tenente, alla fine del conflitto era stato deportato in Unione Sovietica dove aveva scontato una pena di 5 anni ai lavori forzati, ma non ne aveva mai voluto parlare. Mentre è stato testimone diretto degli anni delle due germanie e di quelli del crollo del muro di Berlino. Intorno la metà degli anni ’70 frequentò l’Accademia d'arte di Düsseldorf che, in quel periodo, contava tra i propri insegnanti il pittore Gerhard Richter (oggi ha 92 anni ed è considerato uno dei più grandi artisti della nostra epoca), oltre ai coniugi Bernd e Hilla Becher, pionieri della fotografia concettuale. Tra gli altri studenti, invece, c’erano nomi che negli anni successivi tutti avrebbero imparato a conoscere (come: Katharina Fritsch, Isa Genzken, Andreas Gursky e Thomas Struth). Schütte si avvicinò molto a Richter mentre cercava la sua strada, ma guardò anche ad altri, come all’americano Richard Serra (la cui opera aveva avuto occasione di vedere dal vivo).
A quel tempo si fece notare per l’acume concettuale. Ne è un’esempio “Amerika”: un grande supporto bianco, su cui l’artista, con forza e precisione, ha tracciato migliaia di segni di grafite fino a renderlo quasi completamente nero (il nome dell’opera fa riferimento alle matite a basso costo con cui era stato eseguito il disegno, ma anche al fatto che con i soldi guadagnati da un eventuale vendita sarebbe andato negli Stati Uniti). Ma anche “Große Mauer” (“Large Wall”, 1977), cioè un’opera composta da piccole tele astratte affiancate in maniera da farle sembrare un muro di mattoni. Per realizzare questo pezzo che cita diversi movimenti artistici, Schütte, che nell’estate di quell’anno stava lavorando in una residenza per anziani, aveva esplorato tutti i cantieri e gli edifici abbandonati della zona per riprodurne i colori. I riquadri (tanto per fare un dispetto ai minimalisti con la loro ossessione per l’ordine) erano appesi un po’storti.
Installation view of Thomas Schütte, on view at The Museum of Modern Art, New York from September 29, 2024 through January 18, 2025. Photo: Jonathan Dorado
Ad ogni modo, Schütte, che già allora dava l’impressione di essere un bastian contrario (la curatrice Lynne Cooke, che ha lavorato con lui più volte ha recentemente affermato: “Thomas è un arcicontrario. Se dici sinistra, lui dirà destra”), non voleva ripercorrere i passi di Richter ma neppure dedicarsi all’Arte Concettuale o al Minimalismo (ai tempi in gran voga).
Sarebbe poi diventato famoso per una rilettura espressionista e del tutto personale della scultura classica. Anche se in un certo periodo era stato ossessionato dai piani orizzontali; fissazione curata dall’amore per l’architettura, che si sarebbe tradotto in modelli e veri e propri edifici. Al Moma ci sono tanti esempi di questo filone del suo lavoro, compreso una sorta di rifugio antiatomico a grandezza naturale dall’aria inquietante e inospitale (“Schutzraum” in inglese “Shelter” che significa, proprio, riparo; 1986).
Le sue più note sculture, invece, (sovente figure umane dai volti caricaturali o abbozzati) sono animate da un’inquietudine costante che si riflette nelle forme caotiche e dinamiche. a momenti sul punto di liquefarsi, mentre i personaggi effigiati osservano coi loro occhi vuoti chi gli passa di fronte. Schütte usa i materiali classici della scultura (acciaio, ceramica laccata, persino bronzo), il più delle volte rievocando i monumenti degli antichi o statuette e busti commemorativi che nei secoli passati finivano nelle case della gente. Naturalmente però, il suo approccio all’opera è opposto: i soggetti sono frutto di innesti tra la storia dell’arte, la tradizione farsesca, la scenografia cinematografica, i teatri dei burattini e persino i reperti conservati in formalina nei musei di storia naturale.
Thomas Schütte. United Enemies, 1994. Two figures of modeling clay, fabric, string, and wood on plastic pedestal with glass bell jar. 74 × 9 13/16 × 9 13/16″ (188 × 25 × 25 cm). De Pont Museum, Tilburg, Netherlands. Photo: Peter Cox. © 2024 Thomas Schütte / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn
Un esempio piuttosto chiaro del suo punto di vista sulla scultura monumentale, ce lo da’ “Zeichnung für Alain Colas” (“Disegno per Alain Colas” del 1989). Alain Colas era un velista francese che tentò di attraversare l’Atlantico da solo in motoscafo, l’aveva già fatto e, primo al mondo, era arrivato in America, ma quella volta qualcosa andò storto e né lui né la sua barca vennero mai ritrovati. Era il 16 novembre del 1978, il giorno del compleanno di Schütte. Una decina di anni dopo, Clamecy (città natale di Colas), chiese proprio all’artista tedesco un monumento per commemorare la scomparsa del velista. E lui progettò un busto figurativo su un alto basamento, da ancorare alla baia come fosse una boa, perché ogni giorno l’alta marea lo sommergesse. Ovviamente l’opera non sarebbe mai stata realizzata.
All’inizio degli anni ’90 Schütte venne in Italia; era stato ammesso a una residenza riservata agli artisti tedeschi a Villa Massimo a Roma. Fu per lui l’occasione di vedere le sculture degli antichi, che lo ispirarono. Così nacquero gli “United Enemies”, una serie di sculture in teche di vetro, in cui compaiono due figure in argilla legate l’una all’altra con volti caricaturali affiancati e corpi composti da ritagli di vestiti e altri materiali di recupero. Il susseguirsi di personaggi della serie regala all’opera una dimensione narrativa che fa pensare al cinema: primo amore di Schütte (prima di iscriversi al corso d’arte all’università, aveva preso in considerazione solo quello di cinema, di cui sarebbe rimasto un appassionato spettatore). “United Enemies”, tuttavia, ha una carica trasgressiva che travalica tutto questo. Un critico ci vide le due germanie finamente riunite, e per nulla felici di esserlo. Schütte non si trovò d’accordo. D’altra parte, pare che lui raramente condivida un’interpretazione. E poi i protagonisti delle sue opere sono riflessi di un’ansia, situata in uno spazio e in un tempo indefinito, che in definitiva ognuno può leggere a modo proprio.
Il critico d’arte statunitense Blake Gopnik, in un recente articolo ha scritto (riferendosi a varie sculture del tedesco): “Tali opere rappresentano un ripudio della tradizione modernista in cui Schütte era stato istruito. Rappresentano anche l'intransigenza che è tipica dello Schütte classico”.
Schütte stesso, invece, ha detto: “Cerco di vedere una cosa da cinque punti di vista e continuo a muovermi, lavorando attorno a un punto centrale. Ma cosa sia non lo so. Non appena lo definisci, è finito”.
“Daughter of Freedom”, con la sua saletta di sole sculture di Schütte, rimarrà alla Beyeler Foundation fino al 5 gennaio. La grande retrospettiva del Moma si chiuderà più tardi (il 18 gennaio 2025). Mentre la mostra che Punta della Dogana di Venezia dedicherà a Thomas Schütte si inaugurerà il 6 aprile per concludersi il 23 novembre del 2025.
Thomas Schütte. Vater Staat (Father State), 2010 (detail). Patinated bronze. 149 5/8 × 61 × 55″ (380 × 155 × 139.7 cm). Collection Anne Dias Griffin Photo: Steven E. Gross. © 2024 Thomas Schütte / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn
nstallation view of Thomas Schütte, on view at The Museum of Modern Art, New York from September 29, 2024 through January 18, 2025. Photo: Jonathan Dorado.
Thomas Schütte. Bronzefrau Nr. 17 (Bronze Woman No. 17), 2006. Patinated bronze on steel table. 80 3/8 × 49 1/4 × 98 1/2″ (204 × 125 × 250 cm). The Art Institute of Chicago. Through prior gifts or bequests of Leo S. Guthman, Fowler McCormick, Albert A. Robin, Marguerita S. Ritman, Emily Crane Chadbourne, Florence S. McCormick, and Judith Neisser; purchased with funds provided by Per Skarstedt; 20th Century Purchase and Robert and Marlene Baumgarten funds. Photo: The Art Institute of Chicago / Art Resource, New York. © 2024 Thomas Schütte / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn
Installation view of Thomas Schütte, on view at The Museum of Modern Art, New York from September 29, 2024 through January 18, 2025. Photo: Jonathan Dorado.
Thomas Schütte. Selbstportrait. 30/31.5.75 (Self-portrait: 5/30–31/75), 1975. Oil on nettle cloth. 23 5/8 × 17 11/16″ (60 × 45 cm). Collection the artist, Düsseldorf. Photo: Luise Heuter © 2024 Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn. © 2024 Thomas Schütte / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn