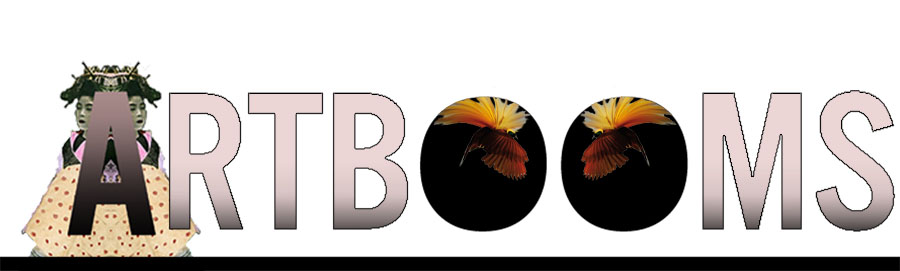"Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole" Palazzo Strozzi, Firenze, 2024. Exhibition view Photo: Ela Bialkowska, OKNO Studio. Courtesy Fondazione Palazzo Strozzi, Florence.
Nata a New York nel 1928, Helen Frankenthaler, è stata una delle artiste più ammirate della sua generazione. Il lirismo che si insinua nelle grandi tele astratte in cui dinamismo e staticità si fondono nei colori ricercati e briosi ha segnato un’epoca, e, da qualche anno ad oggi, a Frankenthaler, è riconosciuto anche un posto di rilievo nella Storia dell’Arte. Nella Storia, lei, che ballò con John Travolta alla Casa Bianca durante un ricevimento in onore dell’allora Principe Carlo e di lady D, un posticino ce l’aveva già.
D’altra parte Frankenthaler, si è inventata una tecnica pittorica tutta sua (‘soak-stain’ letteralmente imbibizione a macchia, in seguito usata anche dai colleghi maschi) e dalla seconda generazione dell’Espressionismo Astratto (la prima tendenza autenticamente americana) ha gettato le basi per movimenti artistici successivi oltre a liberarsi dalla retorica romantica dei suoi predecessori. Da sabato scorso la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze le dedica un’importante mostra nell’edificio rinascimentale che prima di lei ha ospitato grandi nomi del contemporaneo (come Anselm Kiefer o Olafur Eliasson) ma anche antichi maestri (come Donatello).
Curata da Douglas Dreishpoon (direttore dell’Helen Frankenthaler Catalogue Raisonné) e organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi insieme alla Helen Frankenthaler Foundation di New York, la retrospettiva “Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole” ripercorre la lunga carriera della pittrice mancata nel 2011 (a 83 anni). E lo fa attraverso una selezione di opere molto rilevanti di Frankenthaler (alcune sono veri e propri capolavori) ma anche di artisti, a lei contemporanei che l’hanno influenzata o sono stati condizionati da lei.
Ci sono il Jackson Pollock del “nr 14” (1951) che per l’allora giovane pittrice fu un’epifania (in un’intervista di qualche anno fa ha detto: “Non mi piacciono i numeri perché non li ricordo. L'unico numero che abbia mai ricordato è il numero 14 di Pollock(…)”, Morris Louis, Kenneth Noland, Mark Rothko, David Smith, Anthony Caro, Anne Truitt e l’ex marito Robert Motherwell (con cui organizzava sontuosi ricevimenti che riunivano tutto il bel mondo dell’epoca). Per realizzare questo progetto, oltre al materiale fornito dalla Helen Frankenthaler Foundation, gli organizzatori hanno dovuto ricorrere a prestiti di celebri musei e collezioni internazionali come quello del Metropolitan Museum of Art di New York, della Tate Modern di Londra, del Buffalo AKG Art Museum, della National Gallery of Art di Washington, della ASOM Collection e della Collezione Levett. Ne è uscita una mostra che è la più grande mai dedicata in Italia all’artista newyorkese e una delle più complete mai realizzate su di lei a livello internazionale.
"Siamo entusiasti di presentare l'opera di Helen Frankenthaler- ha detto il direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galansino- in una grande mostra senza precedenti in Italia, permettendo al pubblico di scoprire un'artista fondamentale del XX secolo. Con la sua ricerca innovativa, Frankenthaler si è distinta come figura pionieristica nel campo della pittura astratta, ampliandone le potenzialità in un modo che continua a ispirare ancora oggi nuove generazioni di artisti ".
"Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole" Palazzo Strozzi, Firenze, 2024. Exhibition view Photo: Ela Bialkowska, OKNO Studio. Courtesy Fondazione Palazzo Strozzi, Florence.
Del resto Helen Frankenthaler, figlia di un giudice della Corte Suprema e di una ricca signora di origine tedesca (entrambi di fede ebraica), partiva avvantaggiata. Lo studioso Alexander Nemerov in una biografia uscita nel 2021 (“Fierce Poise”) ha scritto: "Figlia dell'Upper East Side, non è mai stata una perdente. Aveva soldi, aveva mezzi e sapeva come farsi strada". Frankenthaler però non ha mai riposato sugli allori, da quando bambina, si interessò di colore e forme, vedendo uno smalto per unghie creare motivi inafferrabili nell’acqua del lavandino: studiò alla Dalton School (NYC) prima e al Bennington College nel Vermont poi; dopo la laurea si affinò privatamente con il pittore australiano Wallace Harrison e per un breve periodo con l’americano Hans Hofmann. Per quanto si sia a lungo concentrata sul lavoro dei cubisti, amava particolarmente Matisse e gli astrattisti europei. Tuttavia, ad aprirle le porte dell’ambiente artistico newyorkese di quegli anni fu il potente critico Clement Greenberg, con cui ebbe una relazione durata 5 anni (dal ’50 al ’55) che si chiuse burrascosamente (a una festa nel West Village, Greenberg la schiaffeggiò, colpendola talmente forte da farla piangere, incurante di tutti gli altri ospiti che stavano a guardare). Ad ogni modo è con lui che conoscerà l’opera di Pollock e capirà quanto una maniera di lavorare più libera e viscerale avrebbe potuto rendere unica la sua pittura.
"Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole" Palazzo Strozzi, Firenze, 2024. Exhibition view Photo: Ela Bialkowska, OKNO Studio. Courtesy Fondazione Palazzo Strozzi, Florence.
Helen Frankenthaler, infatti, dipingeva su grandi tele non trattate appoggiate sul pavimento (da una certa età in poi le sistemava, sempre orizzontalmente, su un supporto per non doversi piegare), muovendosi agilmente tra le grandi campiture di colore come se danzasse (per questo in alcune opere restano quasi impercettibili le sue impronte). Ma è la tecnica che si era inventata ad averla resa famosa: creava delle soluzioni acquose di colore mischiato a trementina e poi, come Pollock, versava i pigmenti direttamente sulla tela che li assorbiva in maniera disomogenea, facendoli propri (il problema di questa tecnica però, in seguito adottata da Morris Louis e Kenneth Noland, è che deteriora il supporto esigendo una continua manutenzione). I risultati sono liriche composizioni vibranti di sfumature, a volte translucide, che a momenti richiamano elementi del paesaggio, ma anche gesti e movimenti. Il tutto trasfigurato. Del resto, l’artista statunitense, che già da giovanissima aveva visto dal vivo e apprezzato i surrealisti, incoraggiava una lettura per libera associazione delle sue opere.
Ma non tutti i critici dell’epoca si entusiasmarono di fronte alla novità arrivando a definire le sue tele “stracci sporchi di colore”.
In genere dipingeva ad olio ma nel corso degli anni usò anche l’acrilico e sostituì la tela con la carta. Fece pure brevi incursioni nella scultura (in mostra a Firenze c’è, ad esempio, “Matisse table” ispirato all’opera di Caro), nella xilografia e nell’arte tessile (va ricordato che la sorella Gloria Ross è stata una designer molto nota per gli arazzi contemporanei realizzati in collaborazione con pittori e tessitori).
"Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole" Palazzo Strozzi, Firenze, 2024. Exhibition view Photo: Ela Bialkowska, OKNO Studio. Courtesy Fondazione Palazzo Strozzi, Florence.
Senza mai perdere lo slancio al cambiamento e all’innovazione, Frankenthaler, ha avuto una lunga carriera (che la mostra a Palazzo Strozzi ripercorre decennio per decennio) ed è stata testimone di momenti storici differenti. Da quando nel ’48 lei e un’amica visitarono il Vecchio Continente ancora devastato dal conflitto che si era appena concluso (Nemerov nel suo libro ha scritto: "un viaggio difficile, non da ultimo perché le banchine dove attraccavano le navi transatlantiche in Europa erano piene di bare di militari americani i cui corpi venivano ancora rispediti a casa tre anni dopo la fine della guerra"), fino a quando negli anni ’80 lei appoggiò la polemica contro a Robert Mapplethorpe (colpevole di aver rappresentato la sessualità gay in immagini decisamente esplicite) e Andres Serrano (che invece aveva fotografato un crocifisso immerso nell’urina) affermando:"Alzate il livello. Abbiamo bisogno di più intenditori di cultura". D’altra parte Frankenthaler era fatta così: non amava la politica e non le piaceva che l’arte si piegasse ai suoi capricci.
Le piacevano invece i mutamenti del paesaggio e l’oceano che ammirava dalle finestre della casa in cui si era trasferita insieme al suo secondo marito (DuBrul Jr, un famoso banchiere d’investimento) a Darien, nelle isole atlantiche, Long Island Sound. L’acqua, la luce e il continuo slittare della linea d’orizzonte di quell’angolo della Costa- est entreranno prepotenti in tutte le sue opere successive.
In un’intervista rilasciata nel 2000 disse: “Sono sempre stata sensibile alle meraviglie dell’ambiente naturale. Quando ero bambina portavo mia madre alla finestra della mia stanza nel nostro appartamento al tredicesimo piano di Manhattan e le chiedevo di guardare le nuvole, perché ero incantata da ciò che potevo vedere fuori dalle finestre, dagli spazi e dai mutamenti della natura”.
"Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole" Palazzo Strozzi, Firenze, 2024. Exhibition view Photo: Ela Bialkowska, OKNO Studio. Courtesy Fondazione Palazzo Strozzi, Florence.
Per quanto il grande pubblico abbia imparato a conoscerla già dopo la retrospettiva che nel ’69 le dedicò il Whitney Museum of American Art (New York), Frankenthaler, è diventata anche (e suo malgrado) un’icona femminista per come il suo nome sia stato a lungo oscurato da quello dell’ex-marito Motherwell e in generale da colleghi maschi meno capaci.
“Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole” è un’occasione unica per vedere dal vivo alcune tra le opere più rappresentative di Helen Frankenthaler (con il bonus di alcuni pregevoli: Pollock, Louis, Noland, Rothko, Smith, Truitt, Caro e Motherwell). Si potrà visitare a Palazzo Strozzi di Firenze fino al 26 gennaio 2025.
"Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole" Palazzo Strozzi, Firenze, 2024. Exhibition view Photo: Ela Bialkowska, OKNO Studio. Courtesy Fondazione Palazzo Strozzi, Florence.
"Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole" Palazzo Strozzi, Firenze, 2024. Exhibition view Photo: Ela Bialkowska, OKNO Studio. Courtesy Fondazione Palazzo Strozzi, Florence. Copyrigth opere: Anthony Caro © 2024 The Anthony Caro Estate / The Design and Artists Copyright Society (DACS), London / SIAE, Roma Helen Frankehtaler © 2024 Helen Frankenthaler Foundation, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York / SIAE, Roma Morris Louis © 2024 Maryland College Institute of Art (MICA), Rights Administered by SIAE, All Rights Reserved Robert Motherwell © Dedalus Foundation, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York / SIAE, Roma Kenneth Noland © Estate of Kenneth Noland / Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), New York / SIAE, RomaJackson Pollock © Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York / SIAE, Roma Mark Rothko © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko / Artists Rights Society (ARS), New York / SIAE, Roma David Smith © 2024 The Estate of David Smith / Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), NY / SIAE, Roma Anne Truitt © Bridgeman Images
Helen Frankenthaler nel suo studio della Third Avenue in una pausa del lavoro su Alassio (1960), New York, 1960. Courtesy Helen Frankenthaler Foundation Archives, New York. Photograph by Walter Silver © The New York Public Library / Art Resource, NY. Artwork © 2024 Helen Frankenthaler Foundation, Inc. / Artists Rights Society (ARS), NY.