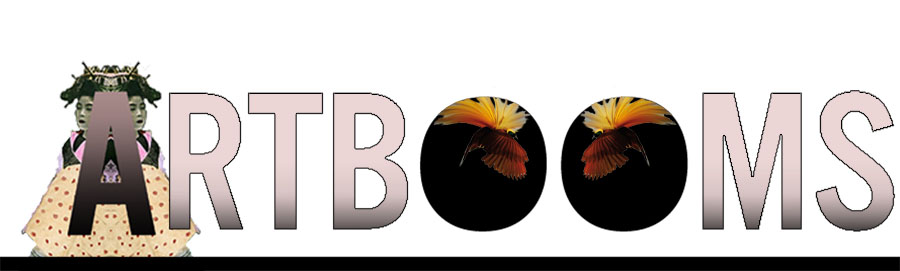Nel cuore del centro parigino il Louvre è più di un museo ma un icona francese. La piramide da cui si accede al palazzo da vista da una delle stanze del museo. Photo ©artbooms
Martedì scorso il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che il Louvre verrà sottoposto a un’importante progetto di rinnovamento. Si chiamerà “Louvre New Renaissance” e prevede sia opere di restauro che lavori di costruzione ed ampliamento. Durerà dieci anni (nel corso dei quali il museo continuerà a rimanere aperto), per una spesa che gli assistenti del Signor Macron hanno detto indicativamente compresa tra i 700 e gli 800 milioni di euro (per avere un metro di paragone molto più di quanto servito per costruire lo Stadio olimpico di Atene e la sede di Bilbao del Guggenheim insieme).
A fare notizia però è stato soprattutto il fatto che la Gioconda avrà uno spazio espositivo tutto per lei "accessibile in modo indipendente rispetto al resto del museo" e con "un suo pass di accesso". Anche il nuovo ingresso, che verrà creato nella facciata est del complesso (vicino alla Senna), è stato argomento di discussione ma con meno entusiasmo di quello dimostrato per lo spostamento del capolavoro di Leonardo.
Del resto il Louvre, con un pubblico di circa 9 milioni di visitatori annui (come se tutti gli abitanti di New York più qualche altro centinaio di migliaio di persone si spostassero in un singolo edificio parigino almeno una volta all’anno), è il museo più visto al mondo. Ovviamente ci sono molti francesi ma la maggioranza del pubblico è composto da stranieri (soprattutto statunitensi e cinesi ma a seguire: inglesi, italiani, tedeschi e spagnoli). E si stima che l’80 per cento di loro sia lì solo per vedere la Monna Lisa (e farsi un selfie con l’iconico ritratto). Nonostante la collezione vasta e spettacolare del museo (circa 500mila pezzi di cui solo 30mila in esposizione).
Per questo era da tempo che si parlava di spostare l’opera. Sempre per questo si pensava ad un biglietto ad hoc. Alla fine l’annuncio è arrivato e le opinioni espresse sul progetto non sono state univoche. Il critico britannico Jonathan Jones ha ad esempio scritto: “È vero che la Monna Lisa rende difficile prestare attenzione ai dipinti di Veronese, Tiziano e altri nella stessa stanza. Ma non è per via della folla. È per la Monna Lisa che è così avvincente. Nella mia esperienza, la folla non rovina il Louvre. Gli dà vita. Un'altra misura pianificata, l'apertura di un nuovo ingresso, sembra più utile perché può esserci una coda lenta per entrare nella piramide di IM Pei”. Mentre molti altri hanno espresso soddisfazione. In fondo, sarà anche bello condividere con altri l’esperienza di ammirare un’opera d’arte, ma da soli, con calma, è meglio.
Effettivamente invece l’unico ingresso attuale, creato negli anni ’80 dallo scomparso architetto cino-statunitense Ieoh Ming Pei su commissione dell’allora presidente François Mitterrand, era uno dei punti critici segnalati al governo dal direttore del Louvre, Laurence des Cars, in un memorandum che era arrivato, non si sa come, alla stampa e che il quotidiano Le Parisien aveva pubblicato. Perché è piccolo rispetto alla mole di persone attese giornalmente al museo e la natura della sua struttura (la forma e i materiali della piramide che lo sovrastano) lo rende rumoroso e caldissimo. Caratteristiche molto fastidiose per i visitatori ma addirittura debilitanti per lo staff (composto da 2mila e 500 persone: cioè più della popolazione dei comuni di Madonna di Campiglio, Portofino e Monterosso messi assieme).
Gli altri problemi segnalati andavano dalle perdite d'acqua alle variazioni di temperatura che mettono a rischio le opere d'arte, dalla mancanza di impermeabilizzazione di alcune aree ai bagni obsoleti, fino alle insufficienti strutture di ristorazione. E poi la segnaletica (il museo, nato come palazzo reale, è un dedalo in cui perdersi è facilissimo; forse anche per questo il ritratto di Leonardo è così visitato: seguire gli altri è più facile che orientarsi da soli). Il signor Macron ha però assicurato che il progetto di restauro sarà “colossale” e che, in sostanza, presto sarà tutto risolto.
Il Louvre, che ogni anno dispone di 323 milioni per mantenere l’edificio (per il 60 per cento provenienti da risorse proprie (come biglietti, merchandising, resa del marchio cui ha fortemente contribuito il museo di Abu Dabi), finanzierà buona parte del progetto (il secondo ingresso, i nuovi spazi e la sala dedicata alla Gioconda). Per poterselo permettere aumenterà i biglietti ai visitatori extraeuropei. Lo Stato, in questo momento in crisi finanziaria, contribuirà invece per 10 milioni soltanto
Il salone interno del Louvre da cui si raggiungono tutte le gallerie inganna e non è sempre facile arrivare dove si vorrebbe anche perchè la segnaletica è carente. Photo ©artbooms