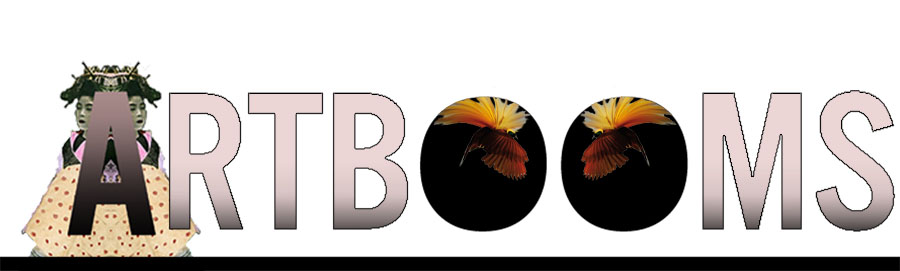Oliver Beer, Rights / Unattained Goals (installation view), 2020, installation, sound, speakers, vessels, mixed media, plinths. Commissioned by the 2nd Riga International Biennial of Contemporary Art, RIBOCA2. Photo by Hedi Jaansoo. Courtesy of the Riga International Biennial of Contemporary Art.
Nell’opera Household Gods (Aspazija), l’artista inglese Oliver Beer, ha raccolto diversi oggetti riconducibili alla scrittrice lettone Aspazija (moglie del più celebre poeta Rainis fu tra le prime femministe della Lettonia), li ha messi su un piedistallo, microfonati uno per uno e ha amplificato la loro voce. Usandola poi per comporre melodie.
E’ un lavoro molto simile ad altri del trentasettenne Oliver Beer. L’artista, infatti, si è convinto presto che dentro ogni oggetto inanimato si nasconda un suono che merita di essere reso udibile ed ascoltato. E talvolta, ma solo talvolta, una nota perfetta. Come è successo al Metropolitan Art Museum di New York nel 2019 quando con Vessel Orchestra ne ha trovate 32. Ognuna stava all’interno di un reperto in collezione al museo ma per scovarle tutte ha dovuto esaminare un gran numero di oggetti. Anzi ascoltarli come si farebbe con i cantanti ad un provino.
"Per questo pezzo, ho ascoltato centinaia e centinaia di oggetti- ha detto ai tempi alla rivista Newyorker- Ci sono pochissimi oggetti che cantano nella sala occidentale. C'era un Brancusi, la "musa dormiente", che avrei incluso. Ma cantava forte”.
Alla fine Beer si decise per un gruppo di voci più multietnico e il cantante più anziano fu un vaso libanese del VII secolo avanti Cristo. I suoni emessi da ciascuno erano collegati a una tastiera e l’artista o chi per lui li usava per suonare, esattamente come si farebbe con le note generate da un pianoforte.
Come in Household Gods (Aspazija) soltanto che in questo caso gli oggetti scelti invece di avere a che fare con la Storia rappresentavano l’intimità. A testimonianza di questo il nome della serie di cui il lavoro, commissionato e realizzato per la seconda edizione della Biennale di Riga (Riboca), fa parte: Household Gods, Divinità domestiche. Cui appartengono anche le installazioni Nonna, Madre e Sorella.
Spingendo la pratica di Beer, già in bilico tra arti visive, performative e musicali (si certe barriere sono già state abbattute da tempo ma mai del tutto), in un terreno sempre più remoto a ridosso del post-concettuale ma irrigato dall’affettività e nutrito dalla poesia.
“Il suo trattamento dei materiali estende il sentimento- scrive di lui la Biennale di Riga- dove vasi con 'voci' si liberano dalle dualità costruite dell'animato e dell'inanimato, del soggetto e dell'oggetto, vivente e non vivente. Questo approccio inquadra il lavoro di Beer nella linea del pensiero animista, una convinzione attraverso la quale si riconosce la forza vitale che anima tutti gli esseri, dai manufatti agli elementi della natura.”
D’altra parte Oliver Beer ha un profilo particolare. Come ci si potrebbe aspettare da uno che oltre agli oggetti fa cantare anche gli edifici. "Sin da quando ero un bambino, potevo sentire le note degli edifici" ha detto al periodico Wallpaper.
Per farlo individua dei punti precisi in cui mettere dei cantanti che spingono l’architettura a suonare da sola. Come ha fatto più di una volta al Centre Pompidou di Parigi (uno tra i tanti capolavori di Renzo Piano). “Quando ci sono andato per la prima volta- ha ricordato recentemente su Instagram- ho scoperto che quando si canta un sol perfetto lo spazio risuona così potentemente che non puoi più nemmeno sentire la tua stessa voce, solo il tunnel di vetro che risuona intorno a te come una vasta canna d'organo architettonica. È una sorta di esperienza indescrivibile e viscerale”.
Un’altra importante intuizione di Beer si trova in Composition for Mouths (Songs my Mother Taught Me). L’opera è nata quasi per caso durante un giorno di prove reso clandestino da una manifestazione: per la sicurezza Beer se ne doveva andare, lui non ne voleva sapere, così ha finto di uscire per poi tornare ma ha dovuto trovare uno stratagemma per non farsi sentire. Così ha chiesto ai perfromers di cantare la prima canzone che ricordassero gli uni nella bocca degli altri. Le immagini sembrano quelle di persone che si baciano con trasporto ma il suono che esce dai loro nasi è una fusione di due voci e due canti. Persino due lingue e due culture.
Oliver Beer vive tra Londra e Parigi. Ha un sito internet e un account Instagram in cui condivide vari momenti del suo lavoro. La Biennale di Riga, in cui avrebbe dovuto presentare l’intera serie di installazioni Household Gods (in realtà Riboca 2 non aprì mai per la pandemia), vedrà la sua terza edizione la prossima estate.
Oliver Beer, Simple Rights / Unattained Goals (detail of installation), 2020, installation, sound, speakers, vessels, mixed media, plinths. Commissioned by the 2nd Riga International Biennial of Contemporary Art, RIBOCA2. Photo by Olga Sivel. Courtesy of the Riga International Biennial of Contemporary Art.
Oliver Beer, Simple Rights / Unattained Goals (Household Gods (Aspazija), (detail of installation), 2020, installation, sound, speakers, vessels, mixed media, plinths. Commissioned by the 2nd Riga International Biennial of Contemporary Art, RIBOCA2. Photo by Hedi Jaansoo. Courtesy of the Riga International Biennial of Contemporary Art.
Oliver Beer, Simple Rights / Unattained Goals (detail of installation), 2020, installation, sound, speakers, vessels, mixed media, plinths. Commissioned by the 2nd Riga International Biennial of Contemporary Art, RIBOCA2. Photo by Olga Sivel. Courtesy of the Riga International Biennial of Contemporary Art.